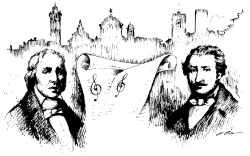
21 Ottobre 2011 - Rita
Per quanto mi riguarda, Rita è una scoperta. Riascoltare e ripensare ad una sua regia mi ha riempito di stupore: è stata un’autentica sorpresa. Lo è, poi, da tutti i punti di vista. È una creazione nata per gioco, quindi per caso: un Donizetti annoiato, solo a Parigi, per ingannare l’attesa di un contratto con l’Opéra che stentava a concretizzarsi, la scrive, così, di getto, senza ripensamenti. E questa Rita – nata senza patemi e senza sovrastrutture – grazie alla sua imponderata spontaneità, si qualifica, con la sua freschezza, come un autentico capolavoro. Le ragioni sono evidenti: in essa sono coniugati istintivamente, senza troppi sterili intellettualismi, il clima scanzonato e vitale della farsa all’italiana settecentesca – ingranaggio scenico raffinato ma di maschere più che di veri e propri personaggi – ed una commedia di carattere di clima borghese: l’opéra-comique, struttura teatrale più evoluta del teatro francese.
Il grande compositore riesce a rendere, senza inutili pose, un ponte ideale tra trovate comiche più immediate e farsesche e arguzie più meditate. Si alternano in scena schiaffi, gioco d’azzardo da taverna (la morra) e da cascina (la paglia corta) con sentimenti veri e profondi, come l’amore in fondo sincero dei due locandieri, arricchiti da dinamiche psicologiche di squisita profondità.
Tutta questa duplicità è resa palese dalla scrittura musicale. A fronte di una simmetria cartesiana di struttura, di spirito mozartiano, una specie di florilegio del numero “tre” (tre arie, tre duetti, un terzetto tripartito), la mutevolezza della scrittura segue, con la sua vivace varietà, il continuo evolversi dei caratteri dei tre protagonisti. L’ambientazione svizzera, il clima della locanda e l’estrazione popolare dei personaggi spingono gli stessi ad esprimersi con spontaneità tra ritmi popolari o locali come barcarole, mazurke, jodler. Ma essi elevandosi, in un giro di poche battute, dialogano con un linguaggio più lirico ed elevato da melodramma romantico, per ritornare poi a battibecchi farseschi o più comici, quando quelle stesse melodie si trasformano in ironiche evocazioni di climi da drammoni di cappa e spada lontani mille miglia dalla prosaica verità della vicenda.
Il vero problema è quindi come rendere tutto questo. Mi sono trovato – come sempre in casi di opere anfibie o meglio bifronti – in difficoltà. Il clima è doppio e doppio è il rischio di non renderlo. La prima tentazione è quella di essere troppo intellettuali o peggio intellettualistici: risultato, si uccide la spontaneità. La seconda, non meno grave, è quella di nascondere la sua lievità e raffinatezza sotto il peso di trovate di facile presa ma di cattivo gusto e di stile inadatto.
Pertanto mi sono attenuto alla linea musicale e da questa mi sono basato per creare il ritmo e la vitalità. Si passerà – con la levigata dolcezza donizettiana – da momenti di lirismo romantico alla parodia di opere serie, dalla spontaneità comica accanto al rossiniano nonsense mimico. Un tratto penso che sia però il più determinante per rendere appieno la sua qualità: creare un clima che abbracci artisti (in scena) e pubblico (in sala) e che ci porti alla mente – sorridendo con sincerità non priva di malizia – le parole della mozartiana Susanna: “Divertiamoci anche noi!” (Le nozze di Figaro, atto quarto, scena decima).
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.
11 Novembre 2011 - Nabucco
La maggiore difficoltà nell’allestimento di Nabucco è riuscire a conciliare una sua grande disparità interna: questo melodramma, in cui si percepisce soltanto a tratti quello che sarà il grande Verdi, ha molto di incompiuto e di anfibio. Il musicista – quasi esordiente e non aiutato da un libretto alquanto farraginoso, nella sua intricata e criptica struttura drammaturgica – crea un’architettura musicale ampia e ricca, ma non completamente coesa. Alcuni aspetti nascono da ispirazioni rossiniane, consimili per clima ed ambientazione (Mosé in Egitto e Semiramide), e non mancano poi echi belliniani, legati soprattutto alla figura di Abigaille, compagna ideale di Norma; sono entrambe donne guerriere, volitive ed androgine, ma la cui corazza, imposta dal loro ruolo sociale, non fa altro che celare una dolce femminilità: un’amante e una figlia frustrate nelle loro aspettative emotive, alle quali solo una morte, che sa di trasfigurazione, può rendere una pace interiore.
Il determinante contributo – del tutto personale – del giovane Verdi si manifesta non solo nei recitativi e nella spinta drammatica che ne consegue, ma anche e soprattutto in un “personaggio” nuovo destinato ad un grande avvenire: il coro, che diventerà il simbolo non solo della novità del genio verdiano, ma, per la sua dirompente straordinarietà, sarà salutato come l’emblema del Risorgimento italiano.
In questo rapido quadro sta racchiusa la grandezza ed il limite di Nabucco: in altri termini, per il suo ruolo storico e per il coinvolgimento emotivo, è più di una semplice opera, ma è anche meno di un capolavoro musicale realmente e compiutamente riuscito.
La mia scelta registica si basa su una decisione ferma, che forse può sembrare assurda: non proporre una lettura tradizionalmente didascalica. È molto difficile accompagnare per mano lo spettatore nelle involuzioni della narrazione e chiarire passo per passo la dinamica delle vicenda: si risulterebbe troppo calligrafici, non si riuscirebbe, poi, ad offrire una chiara lettura drammaturgica e ci si ritroverebbe persi nei meandri di personaggi sempre in continuo divenire e in una narrazione che non si preoccupa di essere lineare (è difficile differenziare un coro che interpreta ora soldati e sacerdoti ebrei, ora fanciulle assire, ora rivoltosi fedeli di Belo ed ancora Leviti). Un’altra conseguenza negativa di una lettura prettamente narrativa è quella di far perdere l’elemento di coinvolgimento patriottico, tratto veramente imprescindibile di ogni vero allestimento di Nabucco.
La mia scelta è quella di propendere per una lettura simbolica della vicenda. La chiave di volta della mia interpretazione nasce proprio da Va’, pensiero (parte III, scena IV): coro simbolo non solo della Unità d’Italia, ma della dignità e della fierezza del Popolo italiano, virtù manifestate maggiormente nelle difficoltà storiche. Ho riscontrato la sua massima temperatura evocativa in due esempi inerenti alla Seconda Guerra Mondiale: il Va’, pensiero è stato il primo brano eseguito nello storico concerto (11 maggio 1946) di Arturo Toscanini per il Teatro alla Scala ricostruito – simbolo della rinascita dopo la devastazione delle bombe – e la celebre poesia di Quasimodo Alle fronde dei salici (1945), parafrasi del testo ebraico (Sal 137,2: «Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre») da cui lo stesso librettista Temistocle Solera trasse le parole della notissima pagina:
Alle fronde dei salici, per voto,
anche le nostre cetre erano appese:
oscillavano lievi al triste vento.
(vv. 8-10)
Per rendere questo clima di consapevolezza, ho deciso di dividere la rappresentazione della vicenda in due grandi aree, rispecchiate anche da un separazione scenica: il popolo è demarcato non tanto come ebraico o come assiro, ma come punto di riferimento attualizzante che richiamerà alla mente il ruolo storico dell’opera e soprattutto la sua valenza di simbolo della consapevolezza italiana; i singoli personaggi, invece, manterranno la loro natura melodrammatica e olograficamente ottocentesca. Queste due componenti agiranno su un piano, anche scenograficamente, diverso. Punto di incontro e di coesione di entrambi saranno il sommo sacerdote Zaccaria ed i Leviti, la cui fisionomia ieratica – connaturata al tempo senza il tempo del divino – renderà possibile un contatto trasversale cronologico e narrativo.
L’uso di proiezioni fotografiche avrà il compito di rendere ancora più evidenti il ruolo storico e spirituale dell’opera, dando a queste pagine – destrutturate dalla narrazione, ma proprio per questo più incisive sul versante lirico – un valore spirituale più che drammaturgico. Scelta registica sicuramente ambivalente, ma, come si è detto, proprio per questo più che mai coerente con uno dei più grandi “casi” lirici della storia: “il” Nabucco appunto.
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.
16 Dicembre 2011 - Carmen
Carmen nasce in un periodo particolare del cammino artistico e culturale francese: ormai il Romanticismo è superato e non si può ancora definire pienamente sviluppato il Realismo; era quindi l’Esotismo che conquistava il massimo consenso. Questa sua fortuna era spiegabile non solo per il fascino che derivava, quasi consequenzialmente, da tutto ciò che era lontano dalla quotidianità e, dunque, assai seduttivo, ma anche per le sue fortissime allusioni erotiche. Un esempio è la grande attestazione dei soggetti “mediterranei”. Questa tendenza si afferma in tutta la produzione artistica, ma, in maniera evidentissima, nella pittura: basti pensare alle tele di Jean-Auguste-Dominique Ingres, legate ai bagni turchi, od ancora alle opere di soggetto nord-africano e greco di Eugène Delacroix.
In questo clima nasce il caso musicale di Carmen: un’opéra-comique che si fonda sulla forte spinta erotica e passionale. Poco importava se questa caratteristica fosse realmente tipica del clima mediterraneo spagnolo, ma era innegabile che questa fisionomia fosse evocata nelle menti e nei cuori del pubblico, dei poeti e dei musicisti. Georges Bizet sente, in maniera molto profonda, questa fascinazione e la descrive con una sensibilità molto acuta. Non voglio intendere che la sua sia una Spagna di maniera, ma è importante comprendere come la sua lettura sia intellettuale e rimeditata e affondi le sue radici nella grande esperienza compositiva francese. In altri termini, non si assiste ad una volontà di ricostruire una reale musica spagnola – unica parziale eccezione è la celeberrima Habanera (L’amour est un oiseau rebelle, atto I, scena V), rielaborazione di un tema autenticamente iberico –, ma quella di offrire un’immagine che rispondesse all’immaginario collettivo.
Questi tratti sono riconoscibili fin dalle trasformazioni operate su un piano drammaturgico tra la novella di Prosper Mérimée (1845) e la vicenda presentata dal libretto (1875). Oltre ad essere ridotto il clima più scopertamente realista, viene creata ex novo la figura di Micaëla, assolutamente non presente nell’originale, nata più da un tributo ideale a Charles Gounod che per ossequio ad un realismo ispanico. Rimane certo l’attrazione per la danza, elemento spagnolo per eccellenza – come nella Seguidille (Près des remparts de Séville, atto I, scena X) o nella Chanson bohème (Les tringles des sistres tintaient, atto II, scena I) –, ma si segnalano ancora come tratti più vicini alla tradizione dell’opera francese che ad una ricostruzione di motivi popolari originali.
Questo aspetto, lungi da essere un difetto, ci dà la possibilità di godere di un capolavoro dove la Spagna è resa epicamente: Bizet la vede e con questo sguardo superiore è restituita oggi a noi come fu donata al pubblico distratto e superficiale suo contemporaneo che non ne capì il valore. Il grande musicista, con l’occhio di un francese, la descrive come una terra misteriosa e sensuale dove valori ancestrali, quali la passione e la gelosia, guidano le azioni dei protagonisti. Per riuscire a rendere questo tratto, il compositore ha creato un’ampia architettura sonora dove convivono aspetti evocatori e ponti musicali ideali, che, grazie a temi ricorrenti, caratterizzano l’opera. Paradigma assoluto di questo è la grande sinfonia dove, accanto a echi spagnoleggianti (tema della corrida e quello del torero Escamillo), si presenta la melodia del destino.
Proprio da questo punto prende l’avvio la mia interpretazione registica. La fusione perfetta di questi aspetti sarà evocata visivamente da un’anticipazione della scena finale: l’arena, l’entrata del torero, il tragico e fatale epilogo dell’amore tra Carmen e Don José. Il resto del melodramma sarà reso con sostanziale fedeltà e attenzione alle note – molto dettagliate – del libretto. Ma per rendere al massimo il clima “esotico”, imprescindibile all’opera, attingerò alla componente oleografica, alla vivacità di colore e alla fierezza insinuante del gesto, senza le quali non può reggersi una efficace interpretazione di questo mirabile esempio di teatro musicale francese.
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.
20 Gennaio 2012 - La bohème
Ho sempre riconosciuto nel libretto de La bohème la sua più evidente novità. Quello che mi affascina non è solo il suo valore letterario, ma il fatto che difficilmente si possa trovare una struttura drammatica tanto sensibile alla descrizione di ogni singolo dettaglio della dinamica scenica: le proposte del testo poetico si innestano con una tale spontanea puntualità sulla sua struttura musicale da creare realmente quella fusione di teatro, poesia e musica che è la vera essenza del melodramma stesso. Questa mirabile e vera e propria disposizione scenica traccia, per una regia, un sentiero vincolante, ma con una misura tale nei suoi dettami da concedere anche un’evidente libertà al regista.
Non voglio, quindi, distaccarmi da un simile modello di struttura melodrammatica autorevole; d’altra parte, non dobbiamo scordarci che il teatro è figlio del proprio tempo e spesso – anche se possiamo accettare, soprattutto nell’opera, delle dinamiche sceniche tradizionali – difficilmente siamo coinvolti dalle atmosfere originali in maniera profonda come il pubblico coevo alla “prima”. Non dobbiamo dimenticare che nella Bohème lo scarto tra il tempo dell’azione («1830 circa») e quello della prima rappresentazione (1º febbraio 1896) era circa di un sessantennio e per questo ho preferito puntare sulla creazione di una ambientazione cronologicamente più vicina a noi, che, mantenendo coerenza con l’originale, la rendesse più comunicativa per una platea odierna.
In altri termini, penso che sia più evocativo e più nostro vedere una Mimì che «sviene» – secondo il dettato musicale e del libretto (quadro primo) – in un modesto abituccio scuro piuttosto che in un improponibile abito scozzese, tanto caro all’iconografia della più consolidata e scontata tradizione. Ritengo, poi, che sia più coinvolgente avere di fronte una Musetta in un aderente abito da diva del cinema del dopoguerra piuttosto che in uno sgargiante e ricco abito in stile “secondo impero”.
Sono convinto quindi che sia più nostro riconoscere quel clima di libertà, di poesia e di amore che taglia il respiro e si manifesta in baci incontenibili non nella Parigi di metà Ottocento, ma in quella di metà Novecento: negli anni Cinquanta. Allora la capitale francese era la Parigi di Jean-Paul Sartre, di Simone de Beauvoir e di Simone Signoret, dei café al Quartier latin, sotto l’Abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Era – e per tale noi la riconosciamo ancora oggi – il simbolo della novità priva di vincoli e catene sia per la cultura sia per la filosofia, ma in maniera più ampia per un approccio alla vita diverso, magari meno facile ma meno conformato, una vita spesso veramente «gaia e terribile» («vie charmante et vie terrible»: Henri Murger, Scènes de la vie de bohème, Préface, 1851).
Ecco quindi come la stupenda definizione che Henri Murger colloca tra le pagine del suo fortunato romanzo, fonte della quarta opera del musicista lucchese, acquisisce un significato più forte, più vicino, più percepibile. Giacomo Puccini, con la preziosa benché difficoltosa collaborazione di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, lo pone come il suggello di tutta la vicenda: questa scelta mostra come i tre vogliano eleggere come protagonista la prospettiva data all’esistenza da un gruppo di giovani che, con le loro scelte e la loro condotta, volevano attestare un nuovo approccio alla quotidianità, fuori dalla convenzione borghese. L’immagine di quella quotidianità polemicamente anticonvenzionale è certamente basata sulla spensierata ed euforica felicità tipica di un Dopoguerra di cui ancora noi sentiamo inconsapevolmente le tracce: sentiamo come facente parte del nostro immaginario collettivo legato a quei personaggi quella fierezza che contraddistingue – per dirla con le parole della Beauvoir – l’«età forte» (La Force de l’âge, 1960). Ma quella esteriore dura scorza non difendeva allora, come non riesce nemmeno oggi, i ragazzi protagonisti dal vero lato «terribile» della vita; la sregolatezza non li protegge dall’unica cosa che non sembra riguardare affatto un giovane: la morte.
Tutti questi tratti visivamente li riconosciamo come propri nelle foto parigine di Robert Doisneau e nell’intimismo urbano di piccole camerette e di disadorni interni del nascente cinema della Nouvelle Vague: la vicenda di Mimì – che entra nella vita di Rodolfo e degli altri ragazzi con la sua candela spenta ed esce abbandonando a terra, nello spasimo della morte, il suo nuovo manicotto – è, dunque, la spinta a quella dolorosa consapevolezza tipica dell’età adulta, descritta con chiaroscuri violenti tipici dai primi film di François Truffaut; la consapevolezza esistenzialista di come l’amore sia sopraffazione e dolore è il concetto che riconosciamo come tipico di Sarte. Colline, Schaunard, Marcello e naturalmente Rodolfo, grazie al sacrificio della fragile fioraia, comprendono di non essere più giovani quando si rendono conto che la morte non è qualche cosa che riguarda solo gli altri. Giunge l’irreversibile allontanamento dai sogni di grandi imprese e dalla gioia di sopravvivere, senza quasi avvedersene, tra gli stenti e le privazioni, considerati un prezzo ragionevole per questa libertà. A questo Mimì si sottrae: con le sue scelte prima e poi con la sua morte offre la possibilità anche agli altri di farlo. Diviene quindi – come capita spesso alle donne, e ne troviamo molte conferme nelle pagine autobiografiche della Beauvoir – l’unico sacrificio possibile e quindi necessario.
Nella mia interpretazione, alla luce irreale di una Parigi bianca di neve e nera di fumi, tra colori violentemente forti di un Quartiere latino in festa e immersi in una lattiginosa alba di periferia, ancora più evidente sarà la consapevole scelta di Mimì di amare Rodolfo, di lasciarlo e di immolarsi per lui, con quel coraggio che a lui tanto difetta. In questa mia lettura, ancora una volta, la vittima non è solo lei, ma anche la giovinezza che rappresenta e che se ne va, non con quella violenza indiscreta che le è stata propria, ma su un sommesso e appena percettibile accordo funebre.
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.
24 Febbraio 2012 - Don Pasquale
Don Pasquale è un’opera particolare e, se volessi usare un termine che oggi, forse, potrebbe sembrare fuori luogo, lo potrei definire come un capolavoro concepito come ormai fuori moda; infatti per la città di Parigi, che accoglieva con sempre crescente successo i grandi melodrammi a tinte forti o che si divertiva con le leggera raffinatezza dell’opéra-comique, un “dramma buffo” tradizionale era decisamente una tipologia teatrale superata.
Questa condizione, però, non è certo un difetto, anzi si trasforma in uno straordinario pregio grazie alla profonda consapevolezza di un Donizetti giunto al massimo della sua maturità: il grande operista, da mirabile e smaliziato alchimista, conosce tutti i trucchi del genere “buffo” e tutti i suoi mezzi espressivi e crea, quindi, l’essenza più pura di questo genere, arricchendolo anche di una profondità psicologica mai riscontrabile prima in opere simili. Don Pasquale diviene quindi l’ultima grandissima opera buffa in stile settecentesco e la prima di quel nuovo genere – quello della commedia umana – che troverà nel Falstaff verdiano la sua seconda perfetta realizzazione ottocentesca e darà i suoi massimi frutti nel Novecento.
È certo l’opera buffa più borghese, più realistica e più amara di Gaetano Donizetti ed anche la più autobiografica (poco ci vuole nel riconoscere nell’infelice e beffato don Pasquale l’ormai non più giovane musicista): è da questa condizione che si giustificano scelte registiche e musicali che puntano su questo versante, inusuale nel genere. Queste interpretazioni determinano una lettura magari interessante e, a tratti, pure geniale, ma priva di quella vivacità tutta da opera buffa, per cui, eliminando questo tratto, si indeboliscono anche i punti più agrodolci resi, per contrasto, tanto intensi.
A fronte di questo, non si deve dimenticare il sorriso divertito ed autoironico che anima tutta l’opera. Lo capiamo dal clima particolarissimo in cui l’opera è nata e si è manifestata apertamente alla sua prima assoluta (Parigi, 3 gennaio 1843), che è avvenuta in quel Téâtre des Italiens in cui trionfavano, nel genere serio, i quattro creatori dell’opera: Giulia Grisi, Luigi Lablache, Giovanni Mario ed Antonio Tamburini, i primi interpreti rispettivamente di Norina, Don Pasquale, Ernesto e Dottor Malatesta. Costoro erano noti al pubblico come gli interpreti di riferimento dei grandi capolavori di Bellini e naturalmente di Donizetti, e quindi il senso di scegliere – almeno una volta – di sorridere era decisamente palpabile.
Questo è quello che mi è sempre sembrato il clima più giusto da imprimere a quest’opera: quel senso di allegria, complicità tra artisti, autocitazione scherzosa ed ironica. Nasce un lieve sorriso, venato magari di amarezza, che solo grandissimi artisti sono in grado di permettersi, quando si concedono uno sfizio. Ecco un solo ma eloquente esempio, nella cui ottica voglio mostrare come l’espediente – vecchio come il mondo della commedia – del travestimento ponga un ponte tra il personaggio e l’artista che l’ha creato: Norina, chiedendo consiglio a Malatesta, si vorrebbe presentare ora come «fiera» ora come «mesta» (atto I, scena quinta) e non si può non leggere in queste parole l’ evocazione scherzosa dei tratti di riferimento di Norma ed Amina, le due eroine belliniane che proprio la Grisi portava in scena con successo proprio in quello stesso teatro. E così pure la scelta finale che punta sulla «semplicetta» il suo capolavoro interpretativo: l’Elvira de I Puritani.
Per rendere questo complesso di caratteri ho deciso di evidenziare gli aspetti divistici, che già sono presenti, nella figura di Norina: le sue intemperanze, le bizze, i capricci la giustificano altrettanto bene quanto la sua creazione della troppo remissiva e dolce Sofronia, figlia della sua credibilità scenica. In una ambientazione contemporanea alla prima, con qualche rapida e sapiente citazione iconografica ai grandi creatori della prima assoluta, si vedrà come a lei faranno corona tutti gli altri personaggi, figure vere e vive perché consapevoli di trovarsi sì in una opera buffa magari anche “vecchio stile”, ma che giocano con puntualità con le maschere più tipiche della commedia: il vecchio stolto e brontolone, il giovane amoroso, il consigliere astuto.
Scioltezza e pertinenza – musicale e librettistica, ma anche quella legata all’estro misurato dei singoli interpreti – le saprà rendere vive e attuali, non rinunciando ad un’amarezza di fondo, ma non riducendo quella che è, sia negli intenti musicali del compositore sia in quelli drammaturgici del librettista, un’opera buffa in un serio dramma borghese.
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.
23 Marzo 2012 - L'Italiana in Algeri
Chi ha a che fare con l’arte è sempre una persona fortunata; vi è poi chi, come me, lavora sui grandi capolavori della musica e ha la possibilità di rinnovare la loro vita, riproponendone una lettura registica: e questo è un autentico privilegio. Ma la mia fortuna non si ferma qui: ciò che maggiormente mi rende ancora più felice è la possibilità di condividere con altri non solo una profonda passione, ma anche la trasformazione di una mia esperienza personale in una occasione di ispirazione.
L’Italiana in Algeri – per i suoi meriti musicali, per la sua vivacità scenica e per il guizzo di puro genio che la percorre – è una delle mie opere preferite. Per molti anni ho conosciuto questo capolavoro, che non è presente nei cartelloni operistici come meriterebbe, solo in incisione e la prima volta che ho assistito ad un suo allestimento teatrale ne sono rimasto non solo affascinato, ma letteralmente stregato. Molto era il merito della musica, ma non certo da meno ero la qualità della lettura registica, che era la ripresa di una celebre edizione del grande Jean-Pierre Ponnelle: uomo di teatro di straordinaria abilità, proprio con L’Italiana ha offerto una lettura che è diventata un classico, un autentico punto di riferimento. Vero punto di forza non sono solo le trovate sceniche originali o la spumeggiante e sempre misuratissima comicità, ma anche una chiarezza narrativa di puntualità strabiliante: l’aderenza alla linea della musica, infatti, è spontanea nello svolgimento della vicenda, resa con quello sguardo ironico e canzonatorio che è la pura sublimazione della genialità di Rossini.
Per questo io mi voglio ispirare a questa regia. Parlo di “ispirazione” e non di “ripresa” per un mio personale desiderio di voler – certo – omaggiare un allestimento “classico” del melodramma riprendendone molti aspetti, ma anche di rinnovarla con qualcosa di mio, per quanto alcune scelte rimarranno invariate rispetto all’originale.
Ecco un paio di esempi. Nella prima scena dell’opera – secondo il modello – il coro maschile si presenterà come un gruppo di pavidi eunuchi intenti al ricamo, immersi un clima dolciastro femminile, accanto a Zulma ed Elvira; l’irrompere in scena di Mustafà, quindi, saprà di terribile e spaventoso, ora come al suo primo apparire al Teatro alla Scala (era il 1973), ma la sua furia fuori luogo darà, oggi come allora, anche evidenti riverberi di comicità.
In alcuni punti, poi, la lezione del grande artista francese sarà solo un punto di partenza. Per la grande scena della prima aria di Mustafà (Delle donne l’arroganza), infatti, ho intenzione di mantenere l’ambientazione in un bagno turco; la voglio, però, caratterizzare in maniera diversa: per ironizzare sul fatuo maschilismo del Bey, lo mostrerò circondato da schiave che, massaggiandolo, gli fanno il solletico. Questo darà un senso “scenico” anche alla autentica cascata di agilità della scrittura vocale, che mi ha sempre ricordato una risata in musica.
Un aspetto che poi voglio aggiungere, disseminato in tutta l’opera, è l’evocazione di un colore locale. Per rendere questo tratto mi servirò di videoproiezioni che riprodurranno i grandi capolavori pittorici dell’Ottocento francese, che hanno come soggetti, appunto, l’ambiente turco: le tele di Eugène Delacroix, di Théodore Chassériau e di Jean-Auguste-Dominique Ingres, infatti, ci trasmettono un alone “oleografico” dell’immagine che, fin dal secolo XIX, noi riconosciamo come irrinunciabile a questo ambiente. Tra tutte le possibili risorse legate a queste immagini, ne voglio prediligere una in particolare: la vivacità quasi violenta dell’impatto cromatico, connaturato con l’ambiente moresco.
Oltre a questo, vorrei presentare un secondo aspetto: quello erotico, legato alla rappresentazione dei bagni turchi, caratterizzato dalla presenza del nudo femminile. Ne nascerà quella sottile, ma penetrante, seduzione esotica e sensuale che era connaturata alla visione – magari anche un po’ favolistica – che si aveva del mondo orientale, ma che, ancora oggi, sentiamo come appropriata e molto evocativa.
Mentre rileggo queste righe ho una strana percezione. Dopo avere sinceramente dimostrato la mia totale ammirazione per la lettura di Ponnelle, decido di porre alcune modifiche con l’intento di migliorare quello che è un capolavoro. Mi dico che lo faccio per adeguarla ai miei mezzi o al pubblico che vedrà il mio lavoro, ma più ci penso e più mi sento un pazzo. Ma un pazzo inteso rossinianamente. Non penso sia un caso che il compositore stesso ed uno dei suoi massimi ammiratori ottocenteschi – Stendhal – leghino il tema dalla pazzia a quest’opera. Rossini, dopo la prima dell’opera (al Teatro San Benedetto di Venezia, 22 maggio 1813), stupito ed incredulo del successo, diceva: «Ora sono tranquillo, perché a quanto pare i veneziani sono più matti di me». Per il grande romanziere-melomane, invece, il finale primo aveva raggiunto il massimo livello compositivo possibile con la sua «follia organizzata e completa» («folie organisée et complète», da Vie de Rossini, 1823).
Ma allora io sono in perfetto clima?
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.
20 Aprile 2012 - Suor Angelica - Cavalleria Rusticana
La scelta di presentare in una sola serata queste due opere brevi non è pratica usuale, infatti queste due opere sono, di solito, inserite in contesti diversi ed ormai ben codificati: Cavalleria rusticana è abbinata, a causa della sua ridotta durata, con Pagliacci e Suor Anglica non nasce nemmeno come un elemento a sé stante, ma è uno dei tasselli del Trittico e Puccini ha concepito questa particolare opera, pur nella natura indipendente di ogni singolo pannello, come un unicum continuo. Questa modalità consolidatissima dalla tradizione le rende pressoché indivisibili.
Proporre, dunque, affiancati questi due capolavori – per consuetudine e per scelta specifica estranei l’uno all’altro – è un’occasione per ricercare i possibili tratti comuni: il mio scopo, infatti, è quello di cercare una rapporto di continuità tra questi due melodrammi, creando una linea espressiva che li leghi saldamente. Mancando una evidente contiguità trasversale tra le due vicende, sia per argomento sia per ambientazione storica, ho cercato e ritrovato alcuni tratti che le accomunano. Il più evidente è l’elemento religioso: il misticismo e la pratica devozionale sono – neanche a dirlo – fondanti in Suor Angelica, mentre in Cavalleria rusticana sono presenti in maniera ora evidente ora latente, quasi serpeggianti in tutta la vicenda, che, non a caso, si svolge proprio nella mattinata di Pasqua; ma essi sono sempre cupi, sanguigni, oppressivi.
Per rendere questa trasversalità ancora più evidente, ho deciso di eliminare l’approccio di religiosità serena, solare e semplice, già di base poco presente nell’opera di Puccini. Ambienterò, quindi, Suor Angelica non nel pacifico e rasserenante chiostro caro alla tradizione, ma in un’ampia sala sotterranea a doppia natura: quella di cripta e quella di carcere. Le uniche sue illuminazioni saranno le luci tanto forti per intensità quanto ridotte per dimensione, idealmente provenienti da lucernari posti in alto nella volta di questa sala altrimenti priva non solo di finestre, ma anche di minimi spiragli. I raggi di sole colpiranno il suolo tagliati da evidenti ombre cruciformi di grate posto a livello della superficie, ma per noi e per le abitatrici invisibili.
Ecco quindi che, con questa lettura, le gioiose giornate «della fontana d’oro» (scena “La ricreazione”) prendono un altro sapore: il miracolo del sole che entra in clausura ed illumina di luce dorata l’acqua di un vasca acquisisce non solo il significato di un evento, ma anche la riprova di quanto la gioia della luce sia estranea a queste anime volutamente recluse. Ben si colloca in questo ambiente sia la cupezza della scena della Zia principessa sia la scena dell’Intermezzo, in cui questo sotterraneo si punteggerà della luce dei lumini sulle tombe pavimentali di altre suore che, benché morte, convivono la stessa cupa prigionia con le consorelle vive; e la sfolgorante luminosità del Miracolo finale si mostrerà ancora più efficace per la sua totale estraneità al luogo dove avviene.
Questo clima cupo, violento e mistico percorrerà anche tutta la vicenda di Cavalleria rusticana, nella quale presenterò una mia libera lettura di una delle più antiche tradizioni siciliani: I Miracoli. Inserirò questi quadri viventi delle stazioni della Via Crucis – previsti, secondo la pratica liturgica, per il Venerdì della Settimana Santa – dopo la Siciliana («O Lola ch’hai di latti la cammisa», a sipario calato), durante l’«Inneggiamo» (scena terza) e alla fine dell’Intermezzo sinfonico (scena ottava). Intendo così rendere anche un certo colore locale tipico delle tradizioni mediterranee, che noi amiamo sentire come connaturate con la Sicilia verista sia letteraria sia musicale.
Altro aspetto che accomuna i due titoli è una passionalità arroventata: questo tratto è portante nell’atto unico del grande livornese e non meno determinante, anche se più sopito, si trova anche in Suor Angelica. Se però in Cavalleria rusticana la sessualità segue la linea tracciata da Verga e viene ripresa da Mascagni in una interpretazione lampante ed evidente, in Suor Angelica questo tratto è molto più insinuante e sotteso ed allusivo. Nella cripta compariranno proiezioni di grandi tele sacre con riproduzioni di quadri seicenteschi di scuola veneta e spagnola, che rappresentano i terribili e mirabili martirî di sante vergini: immagini truci e macabre che, con la violenza dei colori accessi e contrastanti, fondono la sofferta scelta di una assoluta e intangibile verginità con fortissime pene fisiche in forma di altrettante allusioni spirituali e sessuali, perfetto contraltare della vicenda di Angelica. Per fare un esempio, basti pensare al martirio di Sant’Agata, nel quale la violenza fisica mossa da crudeli aguzzini alla fanciulla, che culmina nella mutilazione dei suoi seni, troverà la sua ripercussione nella durezza, tutta psicologica ma non meno terribile, nella «inesorabile» Zia principessa.
Questa figura spietata ci offre un altro carattere cardine comune: la forza decisionale ed il temperamento dei singoli personaggi. Ciascuno di loro, seppure con modalità ed esiti diversi, ne è animato fin nel profondo: alcuni sono asserviti a sentimenti laceranti e totali, come per le figura di Santuzza o di Turiddu, altri ad affetti dissimulati oppure repressi, come nel caso di Suor Angelica.
Le mie scelte registiche vogliono, quindi, rendere evidenti questi legami sotterranei, attraverso richiami velati e sottili allusioni e, nel mio intendimento, voglio rendere i due allestimenti non due copri musicali e drammatici in sé compiuti ed a sé stanti, ma due declinazioni di un medesimo sentimento di passionalità pura, profonda, vera e caldamente mediterranea: al binomio romantico di “amore e morte” vorrei accostare anche quello di “violenza e sacrificio”, “colpa e redenzione”, tutti aspetti fondamentali di due capolavori così diversi ma altrettanto significativi della grande produzione tardo-ottocentesca e novecentesca italiana.
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.