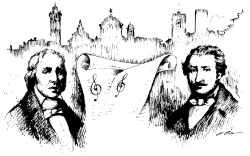
26 Ottobre 2012 - La serva pardona
La Serva Padrona è ambienta a Napoli e del gusto partenopeo mantiene tutta la sensibilità ed il piacere per il cibo connaturato con questa città; non a caso questo delizioso intermezzo buffo è si apre con l’attesa di un ciccolatte. Per questi motivi, forse, ogni volta che mi accingo a pensarne e a farne una regia mi sembra di apprestarmi a preparare un piatto particolarmente gustoso e non uno spettacolo lirico. Senza quasi accorgermi anche le parole che ho usato fin qui mi sembrano più in sintonia con la cucina e non con un palcoscenico. Come molte opere, di scena o di cucina, però, la preparazione sembra semplice solo all’apparenza. Solo quando ti ci metti capisci che, nella realtà dei fatti, è tanto più insidiosa di quanto si pensasse. I motivi dell’equivoco sono evidenti. La sua struttura è lineare, ridotta nel tempo e nello numero dei personaggio e non richiede mezzi di impatto per quanto attiene alla messa in scena. Ripassando per la cucina, per così dire, la portata “Serva Padrona” non vanta la dignità di un piatto veramente sostanzioso, ma, quasi per vendetta a causa di questa semplicità di natura, si dimostra, nella preparazione, molto più “a rischio” di menù solo all’apparenza più complicati. Non dobbiamo dimenticare che nasce come intermezzo: qualche cosa che fa da contorno ad un piatto più elaborato, ma, come nella micro vicenda di Serpina (una sapida servetta che diventa padrona) così, nella storia della musica, questa ghiottoneria, pensata come secondaria, diviene non solo padrona del mastodonte serio di cui faceva parte, ma addirittura regina del repertorio italiano buffo settecentesco. Per questi aspetti, nel mio fare avanti e indietro tra i fornelli e la platea, mi ricorda tanto la maionese: salsa che diviene a volte più importante di quello che accompagna. Nella preparazione di entrambe, infatti, basta un minimo errore per farle subito “impazzire”. Non basta saper scegliere gli ingredienti giusti e freschissimi, ma occorre essere in grado di dosarli ed amalgamarli, lasciando il necessario spazio all’imponderabilità improvvisatoria. Mano ferma e decisione: un “nulla” fuori posto e, nelle le occasioni, possono diventare un bibitone semiliquido e indigesto per qualsiasi stomaco. I rischi di scivolata sono tanti e opposti. Il primo più connaturato ai nostri tempi è di rendere l’intermezzo un gioco sottile di sfiorante ironia, dove è bandita la risata e si vede con sospetto anche un timido sorriso. Molti registi, con la volontà di dare una superiore dignità a questo gioiello, e per allontanarsi dalla criticabile idea del comico, lo spingono verso una seriosità meditativa che non gli è propria. Un po’ come se sembrasse in qualche modo lesivo e limitante vederla e sentirla solo per ciò che è: il capolavoro dell’intermezzo settecentesco; ovvero comicità pura in musica. L’essere stata, poi, la protagonista della celebre disputa, la cosiddetta Querelle des Bouffons,scoppiata in Francia a metà Settecento, non fa che complicare le cose. Ma se gli si vuol fare giustizia il desiderio di arricchirla troppo di densità espressiva ha, come conseguenza, quella di cancellare la sua vivida spassosità, di opacizzare la vivace e volatile semplicità della musica, che si appoggia alla freschezza contagiosa del libretto. Il secondo, non meno grave rischio, è quello legato alla storia del genere buffo, ovvero una versione in cui non solo si accetta l’effettaccio di facile presa ma anche la comicità scontata, con il brontolante e monocorde incedere senile di Uberto e la pettegola esagitazione di Serpina, francamente odiosa. La strada da percorre è quella di mezzo, quindi. Nella mia regia mi sforzo, sempre che questa mia “maionese” non impazzisca, di presentare un settecento spontaneo e, pertanto, fresco. Vorrei dare quel senso di realismo quotidiano di una Napoli che vive l’epoca d’oro dell’opera. Regalare alle figure che vivono la scena un gesto che non ecceda né in una stilizzazione fuori luogo né in una comicità scomposta.
È mio obiettivo fare che la natura inizialmente biliosa di Uberto si stemperi nell’agrodolce, dignitosa consapevolezza della vecchiaia ormai alle porte. Renderò perciò vagamente malinconica la sua grande scena dopo il falso addio dell’amata-odiata cameriera. Il confronto con l’indiscreta sincerità dello specchio renderà quasi palpabile questa scelta. Ugualmente per Serpina. Prima tratteggerò, con un occhio anche alla sua spumeggiante sensualità, la sua natura vitale, polemica e anche un po’ petulante e prevaricatoria; con gestualità rapida e dinamica scattante e sicura. Il maggiore spessore lirico comparirà solo al momento della grande aria, A Serpina penserete; questa sublime pagina segnerà la metamorfosi, rendendoci l’immagine di un’autentica prima donna, maestosa e charmante. Le due figure concluderanno il loro cammino attraverso un’ideale compenetrazione di questi molteplici caratteri nell’ampia sezione finale fatta di dolcezza amorosa e seduzione. Maggiore libertà di azione imprimerò invece a Vespone, pilastro della creazione di Pergolesi: muta, vitale presenza, per controscene ricche di spirito. Dalla lenta e maldestra presenza di servo indolente e fannullone, alla caricata spacconeria del suo alterego Capitan Tempesta. Anche la scelta della scenografia sarà consona. Un susseguirsi di ambienti, che girano intorno ad un unico asse, alterneranno e stempereranno la vicenda in varie microscene. Una cupa camera da letto, un’animata cucina. Una fastosa anticamera, una lavanderia. Una ricca sala da pranzo e, come chiusura ciclica di nuovo la stanza, resa, ora, viva grazie alla presenza della giovane sposa. Ho voluto dare questa idea di circolarità scenografica per rendere chiaro come Serpina sia sempre stata padrona, tanto della casa quanto del cuore del suo Uberto; la maggiore ricchezza che apparirà solo nel finale corrisponde alla consapevolezza che entrambi i protagonisti avranno di questa condizione, ora però resa più profonda, più intima, più vera, più dolce. Il potere dispotico si è mutato in affezione sincera per il sempre amato padrone, che solo dopo il rischio della perdita della compagna, comprende la vera natura del suo sentimento. Ma con la Serva Padrona come con la maionese si deve sempre stare all’erta!
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.
23 Novembre 2012 - Turandot
Turandot è un’opera complessa e pressoché infinite sono le sue implicazioni, spiegabili non solo dalla sua vicenda profondamente simbolica, ma anche dalla ricchissima miniera di innovazioni musicali e compositive escogitate da un maturo e profondo Puccini: non stupisce, perciò, che su questo suo “testamento musicale” sia fiorito il numero maggiore di proposte, di indagini, di letture psicanalitiche e di interpretazioni simboliche rispetto a tutte le altre sue opere.
Molti sono i motivi. Primo tra tutti la femminilità che pervade e si erge vitalissima in tutta la vicenda, una femminilità complessa, duplice, antitetica, oppositiva, che si scorge fin da subito ripartita tra le due figure di Liù e di Turandot: inizialmente – come schiava e principessa – emergono in antitesi, ma, nel prosieguo dell’opera, divengono complementari e, infine, quasi coincidenti, come ad incarnare, nella loro parabola, la pura essenza di un ideale di femminilità totale che non riesce però a mostrarsi completa, ma rimane frantumata in due spezzoni.
Ma questo melodramma è anche – e forse soprattutto – una fiaba. Non che questo dato ne renda più semplice l’interpretazione: l’antropologia e la critica letteraria ci hanno insegnato a rintracciare, in questo tipo di racconti, coinvolgimenti emotivi ancestrali, implicazioni umane profondissime e risvolti onirici e inconsci impossibili da rendere con una regia, se non rischiando di essere troppo intellettuali e di dimenticarne la natura fiabesca e teatrale.
Da questa semplice constatazione prende spunto la mia scelta registica: la lettura che ho intenzione di proporre si sforzerà, quindi, di orientarsi nella resa di quel clima favoloso in cui la fantasia di Puccini inserisce la vicenda della terribile «principessa di gelo» (atto III, quadro primo), grazie all’uso sapientissimo di una musica veramente “incantata”. Ho quindi deciso di sperimentare la collaborazione con una scenografa milanese, Laura Rizzi – che ringrazio per la sua abilità pittorica e per la sua fantasia – che pazientemente ha dato forma e colore alle mie idee ancora incorporee: con la realizzazione dei bozzetti per la nostra produzione; abbiamo cercato di rendere questo complesso di evocazioni, intraprendendo un percorso comune che ha lo scopo di raggiungere una nuova prospettiva di indagine psicologica e possibilmente di rivelare alcuni nuovi lati dei personaggi, percepibili solo se legati a questo tanto irrinunciabile clima fiabesco.
Le fiabe, però, per essere veramente tali, devono parlare all’immaginario collettivo ed è quindi molto difficile trasmettere ad un’ampia e variegata platea il loro “tempo senza tempo”, le innumerevoli suggestioni e quel potere dolcemente evocativo. In più Turandot è anche un’opera, e dunque è dramma e drammaticamente deve essere resa. Ma il teatro, forse più di ogni forma di rappresentazione, è strettamente figlio del proprio tempo; in altre parole, quello che all’epoca della prima assoluta dell’opera (Teatro alla Scala, 25 aprile 1926) era efficace ora può non esserlo più allo stesso modo, ed infatti il clima favoloso del lontano allestimento scaligero del ’26, ancora percepibile scorrendo le vecchie immagini di scene e figurini – pur mantenendo quel suo fascino rétro – perde, ai nostri occhi, la sua immediatezza teatrale.
Pertanto abbiamo deciso di propendere per una proposta alternativa: un qualche cosa che stia tra l’immaginario ed il dramma. Era però necessario, per rendere quel clima familiare tipico della fiaba, un cardine ben specifico e facilmente identificabile a cui fare riferimento e la proposta che maggiormente mi sembrava possibile, come fonte da cui attingere ispirazione, era, ancora una volta, duplice: le illustrazioni dei libri per bambini e la svariata e poliedrica esperienza dei manga. Grazie alla sapienza di Laura, si è cercato di arricchire con tocchi più decisi la placida, luminosa, ingenua e tridimensionale iconografia del libro illustrato di infanzia, fondendola con un figurismo scabro, monocromatico e bidimensionale tipico del fumetto giapponese: scenografia e regia hanno così l’intenzione di evidenziare questo dualismo, con scelte dinamiche e sempre in divenire. La narrazione sarà accompagnata da animazioni grafiche che amplieranno il gesto e la postura dei cantanti, caratterizzando anche alcuni momenti specifici, come l’apparizione della luna, simbolo di femminilità e di morte (Perché tarda la luna?: atto I), il racconto dai contorni mitici di Turandot (In questa reggia: atto II, quadro secondo) ed ancora la grande e simbolica scena degli enigmi (Straniero, ascolta!: atto II, quadro secondo).
A questo punto, però, il vero enigma non son più le tre domande poste da Turandot al Principe ignoto oppure il suo stesso nome, ma quanto questa scelta ardita risponderà alle nostre intenzioni. Al pubblico il compito di scioglierlo!
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.
14 Dicembre 2012 - La forza del destino
Come rapportarsi alla Forza del destino? È un titolone che fa paura ed ogni opera ha la sua storia e fa un po’ caso a sé, ma il timore reverenziale, di fronte a questo titolo, è quasi d’obbligo.
Il “caso-Forza” è certamente uno dei più intricati di tutto il catalogo verdiano e questo è spiegabile sia per motivazioni interne all’opera sia per cause per così dire – esterne. Innanzitutto devo mettere in chiaro un dato: quando ho accettato di stendere queste note di regia come guida e chiarimento alle mie scelte di palcoscenico, mi sono ripromesso di essere totalmente sincero. Non voglio, quindi, nascondere il fatto che quest’opera si porti dietro una nomea non molto lusinghiera e questo non mi lascia certo indifferente. Capita un po’ in tutti gli ambiti: come per gli attori inglesi il nome «Macbeth» è impronunciabile, per noi Italiani che lavoriamo nel mondo del melodramma «Il potere del fato» – denominazione meno compromettente dell’opera in oggetto – pare non sia di buon auspicio. Curare dunque un suo allestimento mi rende un po’ preoccupato, ma ciò non significa affatto che questa fatica verdiana non sia di alta qualità, anzi, è forse una delle opere meglio concepite da un Verdi ormai pienamente maturo.
La piena consapevolezza verdiana – e così giungiamo al secondo motivo di complessità dell’opera – ci regala un dramma ampio, eterogeneo, molto strutturato e sapientemente rivisto nel tempo dal musicista stesso (essendo stato composto nel 1862 per il Teatro Imperiale di San Pietroburgo, oggi Teatro Mariinskij, ma successivamente rielaborato per la sua prima italiana al Teatro Apollo di Roma, oggi Teatro Tordinona, il 7 febbraio 1863). È il primo caso di una rielaborazione non profonda sul piano della quantità, ma assai significativa, poiché – secondo il grande operista – all’indomani della prima russa occorreva cambiare qualche cosa: il punto è comprendere perché ciò abbia portato ad alcune scelte rispetto ad altre. Verdi lasciò, infatti, tutti stupiti e sorpresi quando decise di ripensare il finale (la mutazione che resta più evidente), mantenendo invece altri aspetti considerati più fragili e quindi più suscettibili di rimaneggiamento: questi tratti possono essere facilmente sintetizzati nella scarsa unità di azione e di “clima”.
Dalla corrispondenza verdiana, però, comprendiamo quanto il musicista tenesse sia ad alcune figure apparentemente non adeguate al genere serio della vicenda (prima tra tutti la figura comica di fra Melitone) sia all’apparente spaccatura della trama su due piani narrativi: la vicenda personale di Donna Leonora da una parte e quella di don Alvaro e di don Carlo dall’altra. Questa frammentarietà interna, che si ricompone solo nell’ultima scena, ancora oggi è tangibile, ma, come pensa Verdi – vecchia volpe di teatro – diviene anche la chiave di volta di tutto il particolare spessore drammatico dell’opera stessa. Spesso si è riscontrato in questo complesso clima, autentica risorsa e non limite, un contatto con un altro capolavoro romantico italiano, questa volta non musicale ma letterario, ambientato sempre in un Seicento spagnolo in cui si aggirano frati venerati come santi, e preti meschini: in entrambi i capolavori ci si ritrova gettati tra processioni e guerre di successione e tra monasteri e luoghi inospitali (faccio evidentemente riferimento ai Promessi sposi di Alessandro Manzoni).
Il problema è quindi quello di rendere giustizia a questa complessità di elementi – narrativi ma anche musicali – senza far prevalere un aspetto su altri. Il mio primo intento è quello di assicurare una unitarietà alla poliedricità stilistica scelta dal musicista, cercando ispirazione nella fonte manzoniana per quanto attiene alle scelte di movimenti e di dinamiche dei personaggi, in cui i cantanti – proprio secondo le scelte letterarie di un romanzo in cui sono i semplici e gli oppressi a rivelarci il ruolo della Provvidenza – incarnano con semplicità di gesto e postura realistica il carattere specifico di ogni ruolo: nessuna magniloquenza, nessuna falsa posa scenica, ma quel realismo spontaneo che tutti amiamo ritrovare sia negli “umili” sia nelle grandi figure storiche che popolano il grande affresco manzoniano ed il suo corrispettivo verdiano.
Questo realismo, inteso come eco della realtà romanticamente stemperata e libera dal canone violento e scabro dell’estetica verista, troverà una sua continuità anche in un secondo elemento che propongo come ulteriore collante della mia lettura: la pittura seicentesca italiana, nella quale il realismo si manifesta con prepotenza sia nei temi della quotidianità (basti pensare ai Carracci), ma anche nei temi sacri, con effetto quasi blasfemo (qui penso a Caravaggio). Manca però un elemento: il clima di religiosità cupa, di sacrificio fisico, di ascetismo e di astinenza che sfiora persino la negazione della sensualità più innocente. Per tentare di evocare questo complesso di sentimenti aggiungerò alla pittura italiana anche la coeva produzione pittorica spagnola di El Greco e di José de Ribera: quest’ultimo, in particolare, attivo in Italia col nome di Spagnoletto, fonde le due scuole pittoriche e ne diviene il perfetto medio termine. Per chiudere i grandi temi dell’opera manca quello guerresco: la pittura fiamminga, sempre seicentesca, di Antoon Van Dyck e di Rembrandt caratterizzerà questo aspetto senza voler turbare un clima di fondamentale identità iconografica.
Secondo i miei intenti ne dovrebbe scaturire una lettura coerente e spontanea, dove l’iconografia sia discretamente presente e dove la schiettezza dei gesti dei protagonisti renda più comunicativo il dramma umano, sia esso mistico, guerresco, nobile, amoroso: vorrei, insomma, un dramma vero e vitale, proprio come lo intendeva Verdi. Mi auguro di riuscire in questa mia aspirazione e, se tutto si svolgerà senza intoppi e queste scelte saranno apprezzate, mi ricrederò anche sull’alone iettatorio dell’opera che, magari, incomincerà a portarmi fortuna.
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.
18 Gennaio 2013 - Otello
Il primo sentimento che provo, quando entro in contatto con Otello, è una grande gratitudine ed il motivo è semplice: mi viene naturale concepire quest’opera come una specie di regalo a sorpresa, giunto in maniera tardiva e, per questo, del tutto inaspettato. Noto è, infatti, che Verdi, dopo lo straordinario successo di Aida (1871/1872), non avesse intenzione di tornare a comporre e Otello ci giunge, dunque, come un doppio dono che il grande musicista, a chiusura di una straordinaria carriera, vuol fare non solo a tutti noi, ma anche a se stesso, quale tributo alla sua indomita passione per William Shakespeare. Questa venerazione ha caratterizzato, fin dagli «anni di galera» (1842-1851, come li definì lo stesso Verdi in una lettera alla contessa Clara Maffei datata 12 maggio 1858), tutta la sua parabola compositiva.
Altro pensiero di omaggio – più su un piano pratico, ma non per questo meno importante – emerge nei confronti dell’editore Giulio Ricordi, il quale riuscì ad unire, con il “progettoOtello”, il più grande “vecchio” della tradizione melodrammatica con la testa più “calda” e scapigliata di tutto l’Ottocento italiano: Arrigo Boito. Tale fatto ha veramente del miracoloso, perché non si potrebbe pensare a due modi di intendere l’opera più antitetici.
In conclusione, possiamo riconoscere come con questo dramma Verdi abbia raggiunto una maestosità assoluta sia nello spessore musicale sia in quello teatrale, che certamente gli deriva dal grande tragediografo inglese, ma risulta anche dalla profonda rielaborazione nata dalla vena creativa di Boito, il cui libretto è un’interpretazione decadente e più sottilmente sensuale dell’originale. Il risultato finale, quindi, si chiude visibilmente in una tripla vittoria per queste tre grandi figure di artisti, tre stelle che entrano miracolosamente in risonanza: ecco perché tanta gratitudine!
La mia lettura registica, pertanto, si sforzerà di dare giustizia a queste tre “radici”, primariamente rendendo palpabile questo perfetto amalgama. La chiave di volta della regia avrà come elemento accomunante il poeta Boito, che, rispetto alla fonte shakespeariana, elimina dal libretto il primo atto ambientato a Venezia, concentrando tutta l’azione nella sola isola di Cipro, idea che crea un mondo a parte, ristretto, in un cui la mistificazione della realtà operata da uno Jago - demone del male trovi la sua giustificazione in un ambiente a sé stante. Si pensi a come si apre l’opera: «lampi, tuoni, uragano», la cui caligine densa, anche dopo essersi dissipata, si concentra nella mente di Otello annebbiandone completamente la visione.
Privilegerò, dunque, ambienti scuri, quasi notturni, dove la luce soffocata di Desdemona strida con il buio in cui vive Jago ed in cui questo stesso trascina il cieco Otello. Anche la struttura fisica delle scene mi verrà in soccorso: il primo atto si svolge di notte e nel secondo atto, poi, il palcoscenico si presenterà diviso in due parti, con la sezione retrostante (un giardino) pienamente illuminata, mentre quella verso il proscenio (dove agiranno, perlopiù, Otello e Jago) in ombra. Così come avverrà per il terzo atto, in cui si vedranno i due piani architettonici previsti dal libretto («un vasto peristilio a colonne» e «una sala di minori proporzioni») l’uno molto illuminato ed il secondo sempre in penombra. La scena dell’atto finale, ripresentando un’ambientazione notturna, chiuderà in maniera ciclica l’opera.
La grandezza di Boito, che qui gareggia con quella di Verdi e di Shakespeare, emerge proprio dall’aver creato un ambiente sempre più ridotto, quindi progressivamente claustrofobico, nel quale la furia di Otello, proprio come quella di un leone ferito, in una gabbia – costruita dall’inganno di Jago – che si restringe progressivamente, scoppierà in numerosi eccessi di ira belluina e avrà il suo culmine nella violenta uccisione di Desdemona. Questo concetto di progressiva riduzione degli spazi sarà reso in scena da un prisma in velo bianco che nel corso degli atti, di scena in scena, si chiuderà imprigionando il rude Moro ed il cui colore, sensibile alla luce, si adeguerà al senso dell’azione. La coincidenza tra Otello ed il leone – giustificata dal finale III, in cui Jago calpesterà il corpo del Moro come se fosse quello di una fiera uccisa («Ecco il leone!»: atto III, scena nona) – renderà anche un tributo al clima politico e veneziano dell’opera: non dobbiamo infatti scordare che il simbolo della grande città e repubblica marinara è, appunto, il leone alato di San Marco.
Unica eccezione – voluta – a questo tunnel che schiaccia i vari personaggi sarà il grande duetto del finale I («Già nella notte densa… Mio superbo guerrier!»: atto I, scena terza). Boito non poteva e non voleva rinunciare a quel capolavoro che è la descrizione dell’innamoramento fatta da Otello davanti a Brabanzio, il padre di Desdemona: questa pagina si trova nell’originale primo atto “veneziano”, poi cassato dal poeta, e lo considero, quindi, un momento “a parte” della narrazione. Il finale del duetto parla dell’ammasso delle Pleiadi («già la pleiade ardente al mar discende») e del pianeta Venere («Vien… Venere splende») e la scena non convenzionale, che – anticipando la camera da letto prevista dal libretto solo nel quarto atto – sarà caratterizzata dalla proiezione di un cielo notturno tempestato di stelle, mi offrirà la possibilità di mostrare due costellazioni zodiacali legate indissolubilmente con i due protagonisti: quella del Leone (per Otello) e quella della Vergine (per Desdemona).
Il contatto tra la verginità e la figura della docile dama veneziana non si fermerà solo a questo rimando, perché Boito ha visto una coincidenza tra la figura della donna e quella di Maria Vergine. Desidererei rendere questa sintesi in due momenti specifici: la grande celebrazione di Desdemona dell’atto II («Dove guardi splendono»: atto II, scena terza), sua autentica “santificazione” profana, e, evidentemente, l’Ave Maria dell’atto IV. Nel primo caso mi servirò, nella parte più arretrata della scena, della riproduzione “vivente” del grande polittico di ispirazione gotica Maestà del Palazzo Pubblico di Siena di Simone Martini e nel secondo ripresenterò il medesimo polittico in originale.
In maniera analoga e speculare, Jago, nell’inventiva boitiana, acquisisce una valenza demoniaca, riscontrabile nella celebre aria «Credo in un dio crudel» (atto II, scena seconda), durante la quale i già citati giochi di luce-ombra avranno lo scopo di rendere palpabile il carattere più tipico del Demonio: il buio e con esso la capacità di mostrare, tramite l’inganno, ciò che non è reale come effettivo.
Uomo - Maria Vergine - Demonio: la seconda triade di questo melodramma. Ho iniziato parlando di gratitudine e desidero chiudere queste mie note con una testimonianza di tale sentimento a chi mi dà la possibilità di vivere Otello fin in fondo, cioè di proporre la mia lettura registica. L’elenco sarebbe lunghissimo, quindi: grazie a tutti voi!
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.
9 Febbraio 2013 - Macbeth
Macbeth è una grande tragedia: è un semplice ed incontrovertibile assioma, e a Verdi era chiarissimo. Gli era tanto evidente che dedicò un tempo sterminato e un interesse profondo al complesso dell’allestimento della prima fiorentina (Teatro alla Pergola, 14 marzo 1847). Basti pensare a quanto amasse ricordare Marianna Barbieri-Nini: la creatrice del ruolo di Lady Macbeth non poteva infatti dimenticare le estenuanti prove, le cui queste sedute – non solo in teatro, ma in qualunque luogo disponibile – erano divenute frenetiche a ridosso delle prima («Le prove del Macbeth fra pianoforte e orchestra salirono a più di cento, poiché Verdi mostravasi mai contento dell’esecuzione e richiedeva una migliore interpretazione dagli artisti i quali, un po’ per queste sue esagerate esigenze, un po’ per quel suo carattere chiuso e taciturno non avevano per lui grandi simpatie… E il duetto col baritono che incomincia Fatal mia donna! Un murmure, vi parrà incredibile, ma fu provato più di centocinquanta volte»), tanto che il Maestro costrinse lei ed il baritono Felice Varesi a riprovare quasi tutta la loro parte anche appena prima di andare in scena («Eravamo dunque tutti vestiti e pronti, l’orchestra in ordine, i cori sulla scena, quando il Verdi, fatto un cenno a me e al Varesi, ci chiamò dietro le quinte e disse che per fargli piacere fossimo andati con lui nella sala del foyer per provare un’altra volta al pianoforte quello stramaledettissimo duetto»).
L’interesse maniacale di Verdi emerse anche dalla volontà di sfruttare, per la gran scena delle apparizioni («Finché appelli… Fuggi, o regal fantasima»: atto III, scena terza), la fantasmagoria. Questo dispositivo – raro e costosissimo (una specie di antenato del nostro proiettore) – dava la possibilità di creare immagini evanescenti di grande impatto e, benché più volte gli fosse stato negato, per questioni pratiche ed economiche, era l’unico mezzo ritenuto indispensabile dal musicista per rendere – ed è un termine suo – «l’effetto» adeguato.
Questi aspetti sono solo l’esempio probante della profondità dell’indagine che Verdi ha riservato a Macbeth. Dalle lettere del grande soprano, poi, compaiono almeno altri due dati che ritengo altrettanto indicativi e fondanti per una regia dell’opera. Il primo riguarda la focalizzazione su un numero ridottissimo di scene: Verdi infatti ne riteneva fondamentali solo due: il duetto di Macbeth e Lady prima e dopo l’uccisione di Duncano («Ove son io?… Ora di morte e di vendetta»: atto III, scena quinta) e la gran scena del sonnambulismo («Vegliammo invan due notti… Una macchia è qui tuttora»: atto IV, scene terza e quarta) («Mi ricordo che due erano per il Verdi i punti culminanti dell’opera: la scena del sonnambulismo e il mio duetto col baritono. Si durerà a crederlo, ma è un fatto che la sola scena del sonnambulismo assorbì tre mesi di studio»).
A queste dunque anch’io cercherò di imprimere il massimo risalto: per il duetto ho ideato suggestioni di progressiva sopraffazione delle forze del bene su quelle del male, che al contempo ambientano la presenza delle Streghe; per la scena del sonnambulismo mi concentrerò sull’isolamento della Lady rispetto ai due personaggi, la cui lontananza fisica sarà una metafora intesa a rendere un senso di pietà per la donna, schiava della seduzione del potere.
Il secondo caso riguarda la figura delle Streghe. Nell’epoca romantica, questi soggetti erano letti come figure transumane e toccate da un dono superiore: la capacità di interpretare il futuro. La proposta di Verdi li estende invece a figurazione visionaria e mostruosa dell’ambizione di Macbeth stesso e questa scelta – oggi riconosciuta da tutta la critica letteraria – non era affatto scontata per l’epoca: il Verdi creatore della versione musicale della tragedia shakespeariana è, dunque, prima che un grande compositore, un eccezionale interprete istintivo dei tratti più profondi della concezione drammaturgica di Shakespeare stesso e la vena musicale fa il resto. Ne scaturisce un dramma di inaudito spessore e di grande complessità, quasi palpabile nella resa del valore simbolico delle visioni, delle apparizioni e di tutti gli elementi sovrannaturali che si manifestano lungo tutta la vicenda.
Risorsa peculiare che sfrutterò è la logica attualizzazione della fantasmagoria: la videoproiezione. È evidente che l’impatto di una proiezione oggi non può essere paragonato a quello che avrebbe dato al pubblico della “prima”, stupito dalla inusuale novità del mezzo; in questo caso, però, le immagini non accompagneranno tutta la vicenda fungendo da scenografia, ma caratterizzeranno solo alcune scene: quella delle Apparizioni – secondo il dettame verdiano – e, all’inizio dell’opera, quella del Coro di streghe, in corrispondenza con la loro prima comparsa.
Queste creature disumane saranno maggiormente presenti rispetto a quanto richiesto dal libretto: palpitanti sotto un telo nero, o più evidenti con movenze serpentine, accompagneranno tutta la parabola del nuovo re di Scozia e della sua smodata sete di potere. Loro gli porgeranno il pugnale che si aggira minacciosamente nell’aria prima dell’assassinio di Duncano; per opera loro comparirà, al banchetto, il fantasma di Banco; saranno ancora loro a rendere Lady Macbeth lo strumento di degenerazione morale e di conseguente dannazione di Macbeth: la protagonista stessa ne resterà fagocitata, quasi a diventare una di loro, ed a lei le Streghe recheranno la lettera che scatenerà la sete di potere e di distruzione della donna.
La mutazione di Lady diverrà irreversibile al “brindisi” («Salve, o re!… Si colmi il calice»: finale II), in un clima allucinato, spaventoso e palesemente macabro. Proporrò in questa scena uno scontro violento di aree cromatiche: il nero del palcoscenico, il bianco della tavola, il rosso del vino. Un triangolo e dei piani inclinati segneranno il tratto aggressivo, rabbioso e solitario dei due personaggi ed i colori amplificheranno questo effetto, accompagnando lo svolgimento della vicenda.
L’opera – come Verdi ben ci indica – non è fatta però solo di streghe e di due sovrani; agli altri personaggi – sono padri e figli – mi piacerebbe offrire una maggiore umanità, rendendo evidente il loro spessore sentimentale e questa profondità, sconosciuta agli “sterili” protagonisti, si evidenzierà in colori morbidi e pastello.
Per concludere introdurrò nel finale una nota positiva e rassicurante: il nero delle Streghe che trascinano il cadavere di Macbeth si scioglierà, come una neve sudicia e corrotta, alla luce ed al calore di una nuova alba rosata, la fine di un incubo sanguinario e terribile.
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.
22 Marzo 2013 - La figlia del reggimento
Nei miei ricordi La figlia del reggimento è la prima opera – mi verrebbe da dire “minore” – di Donizetti che ho veramente amato, rendendomi solo successivamente conto quanto il mio affetto nei suoi confronti fosse meritato ampliamente, oltre ad essere condiviso da molti, forse più all’estero che in Italia: questo lavoro condivide, infatti, una “statura” paragonabile a quella di capolavori blasonati come L’elisir d’amore e Don Pasquale. Non a caso, se si scorrono locandine e cartelloni, La Fille du régiment è molto presente non solo nei grandi teatri francesi – come farebbe supporre e giustificherebbe la sua natura linguistica – ma anche in molte sale europee ed americane.
Sia come sia, si tratta di una creazione piacevolissima, affascinante, spigliata, ma soprattutto che offre molte risorse interpretative: nata dalla fantasia di un Donizetti ormai maturo e consapevole del suo valore, possiede una forza vitale travolgente e incontenibile, oltre che una orecchiabilità contagiosa, aspetto che ho sempre considerato forse il suo più grande pregio. Questa tipologia di musica è poi la quintessenza della stessa vicenda, ma La figlia è anche un grande dramma buffo inteso all’italiana e quindi – proprio come i più “complessi” fratelli italiani – sviluppa imprevisti ed ancor più soggioganti risvolti lirici.
L’edizione proposta in questa occasione dal Circolo (in italiano e con i recitativi cantati al posto dei dialoghi recitati della versione francese) ci offre l’occasione di riapprezzarla e di riscoprirla in tutta la sua potenzialità. La mirabile commistione di genere è resa ottimamente da Donizetti, ma pone notevoli problemi registici, allorché sarebbe facile prediligere un tratto rispetto ad un altro, rompendo quell’equilibrio che la rende una delle più ricche e ben riuscite opéra-comique di sempre.
La mia regia si pone di restituire il giusto corrispondente scenico a quel volteggiare vaporoso e spensierato offerto da una musica di immediata attrattiva e di porre poi in giusto rilievo, senza intellettualismi, la virata – improvvisa ed inaspettata – verso un’inventiva compositiva che si fa via via più profonda ed intensa. Ho quindi tentato di schematizzare le idee, riconoscendo ed isolando alcuni elementi particolarmente caratterizzanti: dei soldati bonaccioni, un po’ attempati, a metà strada tra padri e zii, magari un po’ burberi ma mai veramente violenti; un amore contrastato e venato, fin quasi alla fine, da una sorta di asessualità; una vecchia zia acida e petulante, che poi si riconosce essere una madre amorosa e sensibile. Da questi tratti tutta la vicenda mi appare come una “storia della buonanotte” di fine Ottocento, che sa un po’ di favola e un po’ di svago per dei fanciulli di buona famiglia.
Questa mia idea ha trovato conferma e ulteriore sviluppo anche dalle grandi doti grafiche e iconografiche della scenografa Laura Rizzi e – grazie alla collaborazione di questa narratrice per immagini del mondo dei ragazzi, già mia compagna nell’avventura musicale di Turandot – idee sospese hanno preso forma e colore. Di comune accordo abbiamo deciso di spostare l’epoca dell’ambientazione dal Secondo Impero francese (1852-1870, per noi poco evocativo) ad un soffuso clima da Belle Époque (1895-1914): vorrei sentire e far percepire al nostro pubblico quel profumo, nato tra giochi di soldatini e di bambole, che si sarebbe respirato in una stanza di bambini della borghesia fin de siècle francese o austriaca (non dimentichiamo che l’opera è ambientata, nella versione francese, in Tirolo o, nella versione italiana, in Svizzera). Questa ricollocazione temporale ed ambientale appare congeniale per porre in evidenza sia i tratti sentimentali sia quelli ludici e comici di questo «melodramma giocoso», che prenderanno forma e vita in un mondo di bandierine e guerrieri innocui, di pianoforti tascabili dai suoni sgraziati e di dame-bambola con improbabili acconciature rococò, nel quale acquisiranno un loro nuovo valore le affascinanti case di bambole e i loro arredi raffinatamente ingenui. Ed ancora i soldatini, con le loro divise tutte uguali, i loro fortini e le loro innocenti battaglie nello sfondo di montagne alpestri palesemente dipinte saranno la cornice e si fonderanno con l’amorosa vicenda della vivandiera Maria e del giovane paesano Tonio.
Nel nostro intento, queste scelte grafiche – accompagnate da una rosa di costumi intonati – restituiranno un clima di lievità e gioia, ma anche di scherzo e di gioco, di amore e di baci casti dati sulle guance, ed il gesto sobrio e misurato dei personaggi accompagnerà e guiderà l’indiscusso talento dei cantanti. La musica di Donizetti farà il resto.
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.
19 Aprile 2013 - Il trovatore
Il trovatore è un’opera simbolo: con il suo Medioevo oleograficamente ottocentesco, con i suoi cavalieri, con i suoi castelli notturni, con una «cuna» violata da una zingara vendicativa, con streghe fittizie e roghi reali, con voci dal cielo e chiostri illuminati da torce, con richieste di vendette ed immagini di morte, è una delle manifestazioni più alte e di maggior riferimento del melodramma romantico. Non la rendono tale solo la vicenda o il libretto, ma anche la capacità compositiva, la sensibilità strutturale e la forza drammatica versata a larghe mani da Verdi: è evidente che il grande musicista di rado è stato tanto ispirato nella composizione delle melodie, ma il suo merito maggiore non va ricercato solo nel singolo numero o nella melodia di una pagina, bensì nella perfetta aderenza al modello tradizione “romantico” e nella sua profonda caratterizzazione su un piano scenico.
Il trovatore, infatti, non è certamente un’opera innovativa e potremmo anzi azzardarci a definirla “ordinaria”: essa appare pienamente rispondente alle richieste e alle velleità del pubblico, e a tutti gli effetti risulta tradizionale anche la sua struttura musicale (già il grande critico Abramo Basevi – nel suo celebre Studio sulle opere di Giuseppe Verdi del 1859 – riconosceva quanto Verdi avesse proposto un melodramma composto da un ininterrotto susseguirsi del tassello musicale più comune, tanto invalso nella struttura operistica da essere definito «la solita forma»). Questo, che potrebbe apparire come un limite, è invece la base su cui si è costruita la profonda maturazione del musicista: l’abilità di Verdi è stata, quindi, quella di dare al modello stilistico tradizionale – magari un po’ consunto – una logica drammatica e un’urgenza scenica fino ad allora non solo mai viste, ma persino impensabili.
Scenicamente – oserei dire anche visivamente – Il trovatore è pertanto un’opera molto radicata nel momento storico in cui è nata e mostra appieno questo suo carattere a partire dall’ambientazione; ma il setting, in sé, non può bastare a suscitare nel pubblico di oggi le stesse suggestioni di allora e per questo mi sono posto l’obbiettivo di rendere evidente lo spirito originale con una serie di connotazioni riferibili al momento storico della sua creazione.
Presenterò un allestimento basato su due piani di visione prospettica differente: il primo è quello del tempo della vicenda narrata («il principio del secolo XV») ed il secondo è quello del momento storico in cui l’opera è stata applaudita per la prima volta (19 gennaio 1853). Ho colto questa idea potenziale da un grande capolavoro cinematografico degli anni Cinquanta: Senso diretto da Luchino Visconti nel 1954. Il film, ambientato nella Venezia del 1866, si apre con un’immagine del Gran Teatro La Fenice dove si sta dando, appunto, Il Trovatore e – dopo la celeberrima «pira» (parte III, scena sesta) – al grido «All’armi!» il pubblico veneziano getta dal loggione volantini tricolori a mo’ di coriandoli su una platea di ufficiali austriaci. Dal capolavoro viscontiano ho tratto anche alcuni spunti “estetici”: la luminosità pacata delle scene, la gestualità a tratti accademica secondo uno schema forse più operistico che cinematografico, mentre, per la collocazione dei personaggi e dei figuranti, mi sono riferito principalmente ai dipinti di soggetto medievale di Francesco Hayez, pittore “operistico” per eccellenza.
Da tutti questi spunti nasce la mia proposta, che apparirà come una “narrazione parallela”: accanto al nucleo della vicenda primitiva – bloccata in tableau vivant idealmente vicini al grande pittore veneziano – prenderanno vita comparse e figuranti in abiti ottocenteschi, che renderanno palese questa duplicità di visione. La musica animerà poi – di fronte agli occhi di un muto pubblico ottocentesco in scena – queste grandi tele di clima romantico, offrendo un’insolita chiave di lettura legata a gesti codificati e ad abiti di un medioevo tradizionale e placidamente oleografico.
Il mio Trovatore-Senso sarà quindi, nelle mie intenzioni, più visivo e meno narrativo, più scenico e meno drammatico, più storico e meno tradizionale. Mi auguro che da questa operazione emerga intatta la mia fedeltà sostanziale alle richieste di Verdi e, forse, un po’ di quel fascino che il suo Medioevo doveva esercitare agli occhi di un abitante del lombardo-veneto.
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.