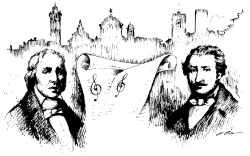
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.
26 Novembre 2010 - La Traviata
Non so quante volte abbia ascoltato La traviata, la innumerevole massa di pagine critiche lette e – benché non vanti una lunga carriera registica – le non poche occasioni in cui l’ho portata in scena; si potrebbe arguire che la conosca a fondo, ma, per me, mantiene sempre un carattere enigmatico, misterioso. E mi sono chiesto il perché. Ho incominciato, quindi, a pensare che fosse qualche cosa legato alla incompatibilità di comunicazione tra la ragione maschile (quella dei doveri e quella delle regole) e la sensibilità femminile (quella legata all’amore e alla libertà). Un fatto che mi ha convinto della validità di questa mia interpretazione è quanto poco Violetta parli realmente con Alfredo e, anche quando lo faccia, il più delle volte realmente non si comprendano. Anzi possiamo dire che non creino quasi mai una vera comunicazione: è come se Violetta sperasse vanamente che lui capisca, ma abbia la consapevolezza di essere sempre delusa in questa sua aspettativa.
Allora un’idea ha incominciato a darsi forma: che questa fosse una vera opera al femminile, un dramma che usasse un linguaggio proprio, un’opera insomma in cui le donne – Violetta, Annina e Flora – parlano una lingua non del tutto comprensibile agli uomini che le circondano. L’opera è cominciata ad apparirmi come la dilatazione di un unico urlo lacerante che proclamava l’amore di Violetta: infelice perché effimero, insensato perché inutile, disperato perché incomprensibile, ma sublime perché disinteressato, memorabile perché inviolato, divino perché eterno.
La cosa che ancora più mi affascina è come Verdi abbia potuto rendere questo aspetto. Forse la consapevolezza di questa capacità è l’unico vero motivo che l’abbia spinto a musicare un dramma simile, tanto lontano dal gusto dell’epoca e dalle inclinazioni precedentemente mostrate, toccando una vicenda a lui contemporanea, caso unico in tutto il suo catalogo. Pertanto penso che quello che l’abbia affascinato sia stata – più che un improbabile elevato valore scenico di una creazione teatrale particolarmente felice – la veridicità totale di un dramma legato a quella incomprensione che, tanto spesso, esiste tra uomini e donne e che forse egli stesso conosceva.
Questo tratto è ancora più evidente nel romanzo, che certamente Verdi conosceva ed al quale ha attinto soprattutto per ricrearne il clima e restare legato alla sua struttura narrativa. L’ampia novella, che palesemente si ispira alla Manon Lescaut di Antoine François Prévost, è – come il modello settecentesco – un grande flashback. Solo il distacco e la reinterpretazione dei fatti, posta dopo la morte stessa della donna, è il solo modo per Armando Duval, il verdiano Alfredo, di capirne le scelte e il dramma interiore, terribile perché non compreso a tempo debito e quindi non condiviso ne ormai più discutibile, avendo la morte posto un limite invalicabile tra i due. A questo stesso è concessa solo una comprensione parziale, perché non chiarita dalle parole, ed inutile perché tardiva, ma accettata e sentita come prova sublime di un amore superiore perché trasfigurato dal sacrificio silenzioso e dalla morte solitaria di Margherita, colei che sarà Violetta.
Verdi rende benissimo il primo aspetto, collocando – pratica assolutamente non usuale per lui – due preludi, che creano una ciclicità al taglio narrativo imposto. L’uguaglianza delle prime battute rendono ancora più evidente questo tratto. Il primo preludio non è l’evocazione di un clima di festa sensuale ed orgiastico, ma una evocazione di morte dove appare, come in un sogno, il tema di Amami, Alfredo (atto secondo, scena sesta), culmine del dramma di Violetta; come nel preludio all’atto terzo, che dimostra una continuità con il suo cupo clima sepolcrale, rotto solo da freddi bagliori che rendono palpabile la consapevolezza di una fine ormai imminente. Più difficile era – ma resa con maestria da Verdi – un’idea di solitudine che sempre accompagna la protagonista, sola perché diversa e, perché diversa, disposta e quasi assetta all’espiazione delle sue colpe, ma non alla rinuncia alla nobiltà dell’amore.
Su questi due punti verteranno le mie scelte registiche. I due preludi saranno, infatti, due punti narrativi nodali. La notorietà enorme dell’opera rende la maggior parte del pubblico disposta a cogliere il senso del flashback, mostrando nelle prime battute del primo preludio dapprima una tomba e poi una Violetta moribonda sul letto di morte. Questa scelta offre anche la possibilità di presentare tutta la vicenda come una meditazione su tutto il dramma di Violetta, vista non solo come ricordo di una moribonda dal su letto, ma come immagine astratta e completa di tutta la vicenda, unica possibilità di ottenere una consapevolezza maggiore perché letta in tutta la sua complessità dal suo primo momento fino alla fine. Il taglio narrativo dato a tutta la vicenda, infatti, è quello della solitudine di una tomba, che ci lega ad una riappropriazione di un ricordo di una Violetta malata, ormai prossima alla morte, che rivisita, nella sua mente, come in un terribile incubo, tutta la vicenda che la lega ad Alfredo. Una figura evanescente, in camicia da notte, sarà compagna alla Violetta sulla scena, immagine tangibile del ricordo, della comprensione del valore delle sue scelte e del suo dramma solitario.
Per rendere appieno il senso di solitudine e di abbandono – uno dei tratti più felici dell’opera – ho deciso poi di operare una particolare scelta registica per il terzo atto. Secondo un fortunato espediente verdiano, che faccio mio, la scena sarà divisa in due parti: una quella della realtà, dove vediamo una Violetta malata, con l’unica compagnia di Annina, e l’altra quella della visione del delirio. In questa seconda sezione la stessa malattia, come se sentisse pietà della sua vittima, le dona fallaci immagini di ciò che le è più caro: il ritorno di Alfredo, una speranza di salute e di amore, l’affetto paterno di Germont. Violetta, dunque, come nella creazione di Alexandre Dumas, muore sola e solo dietro il velo del delirio ella vedrà immagini di un’impossibile felicità futura.
Questa mia interpretazione vuole presentare una creatura che possiamo forse comprendere meglio: ecco quindi la nascita dell’immagine impalpabile, quasi lunare, di un’anima che si aggira tra i suoi ricordi accostandosi, consapevolmente, alla sua tomba. Figura più romantica che realista, ma che nell’illusione donata dal delirio accarezza un sogno di felicità che mi pare più reale nel suo valore onirico di quello proposto letteralmente da Verdi. Magari pare solo a me e forse non ho compreso il vero senso della sua vita scenica, ma proprio per questo mi sento quindi in debito con lei e non vorrò mai negarle questa fallace speranza di felicità, perché offrendolo a lei finisce che, poi, ci credo anche io. E l’opera serve a questo, a sognare.
“A mio nonno Pino, che non amava l’opera ma sentiva il dramma di Violetta
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.
21 Gennaio 2011 - Norma
Allestire un grande capolavoro è sempre compito arduo, ma forse, proprio per questa sua difficoltà, è quanto mai attraente: viene infatti offerta una occasione di riconfrontarsi in maniera diversa – oserei dire quasi operativa – con una grande creazione teatrale e musicale. Nascono numerosi interrogativi, non certo sul valore o sui pregi dell’opera, ma su come si possano rendere al meglio e si riescano a rappresentare con più chiarezza e completezza al pubblico.
Il mio punto di partenza per intraprendere un cammino di allestimento è un confronto tra il dramma originale o la vicenda storica o la pièce teatrale da cui è stata tratta la vicenda dell’opera e la sua definitiva redazione: per comprendere la vera originalità dell’opera – e naturalmente Norma non fa eccezione – non sono i punti di contatto con l’originale, ma piuttosto lo sono i cambiamenti. Il dramma Norma, ossia L’infanticidio nasce a Parigi nel 1830 dalla penna dell’accademico tardo neoclassico francese Alexadre Soumet.
Si nota subito un elemento che sarà il punto di partenza della mia interpretazione registica: Romani e Bellini eliminano un tratto che Soumet riteneva tanto determinante da porre fin dal titolo: “l’infanticidio”. Questa scelta di eliminare l’uccisione dei figli è veramente chiarificatore. Nella sua versione originale Norma non era altro che una tragedia in cui la protagonista era una delle mille declinazioni della figura della infanticida per antonomasia di tutto il neoclassicismo teatrale: Medea, assassina e madre, amante respinta e tradita, donna ferita e maga furibonda. Ma Bellini e Romani volevano qualche cosa che fosse diverso: nasce allora dalle ceneri di una convenzionale figura di semi-dea una nuova figura di donna vera perché fragile, comprensiva perché respinta, sublime perché consapevole. Non uccidendo i figli, la spergiura sacerdotessa abbandona il consueto clima neoclassico del mito per entrare nel grande turbine del romanticismo dove tutto e tutti sono sottomessi alla violenza del sentimento, causa e fine, scopo e guida del cammino che ogni figura di questo dramma sta percorrendo.
Il fatto che Norma non riesca a spingere se stessa ad uccidere i propri figli e non voglia cancellare l’emblema evidente della sua colpa e non senta come possa trarre da questo delitto la gioia disumana che le darà il dolore inferto a Pollione mostra quanto sia nuovo questo personaggio. In altri termini Romani e Bellini leggono romanticamente quello che – nel suo aspetto originale – non è che un semplice, magari astuto per certi passaggi, drammone neoclassico. Ed è in questo clima duplice che risiede tutta la sua grandezza: Norma è un personaggio di natura anfibia; la sua originale natura disumana e fiera vive solo quando esistono le regole che le sono imposte, ma diviene dolce, comprensibile, fragile, quasi remissiva quando è semplicemente donna. Solo in nome del sentimento, che può provare, riesce a trovare in se stessa questa seconda natura – la sua più autentica – e, grazie a questo sentire, con il suo sacrificio finale non solo espierà le proprie colpe, ma in regola di quell’“assurdo” tipicamente tardo-romantico, invece di perdere definitivamente l’amore di Pollione lo riconquisterà, in maniera del tutto impensabile.
Questo è il suo vero carattere, ma la protagonista contamina tutti i personaggi che vi agiscono: ecco quindi che siamo di fronte ad una creazione così fortemente romantica proprio perché – affondando le sue radici in un neoclassicismo di fondo e di maniera – se ne distacca, creando un continuo contrasto che diviene il tratto tipico dell’ordito drammatico stesso.
Ora il vero problema è rendere questo sulla scena: creare un corrispettivo visivo alla creazione romantica per eccellenza creata dalla musica di Bellini. Un bosco notturno, intricato, cupo, impraticabile, selvaggio sarà il luogo angusto ed inospitale dove si aggireranno, alla luce incerta di rade stelle e di raggi lunari, personaggi ora vitali ora evanescenti, che vivono nell’incertezza e nella paura, seguendo come unico incerto faro il loro stesso sentimento, senza avere idea a quali porti li possa mai condurre. Gli alberi si muteranno poi in una selva ancora più claustrofobica di colonne romane, rese ancora più opprimenti della freddezza del loro marmo nella abitazione di Norma. Solo nel finale la scena del bosco troverà nella corrusca luce del rogo, con la luminosità purificatoria del fuoco sacro, una ampliamento fisico e spirituale della scena; Norma – scegliendo infatti di scarificarsi, di salvare l’innocente Adalgisa e di preservare la vita dei figli – attesta il suo messaggio di realtà di un sentimento puro: questo rende consapevoli, come già era avvenuto per la giovane novizia, anche Pollione, Oroveso e anche la comunità druidica. Tutti ora sono liberi dalla oppressione di spazi ridotti e le fiamme che consumano il loro opprimente bosco sacro e sembrano lambire tutti quanti e non solo i due amanti ora riuniti, pur dando morte, assicurano la serenità di una consapevolezza difficile da raggiungere perché superiore.
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.
18 Febbraio 2011 - Il barbiere di Siviglia
L’assoluto valore del libretto, del felicissimo e vitale connubio tra la qualità della musica, del piglio scenico e, di conseguenza, di quello comico rendono unico Il barbiere di Siviglia: unicità assoluta e senza confronti nella storia dell’opera.
Dopo la metà dell’Ottocento, tra tutti i pur efficaci espedienti di personaggi comici, solo gli intrighi di Figaro riescono a sopravvivere a tutte quelle tendenze operistiche che – non solo del genere buffo, ma di tutto il teatro rossiniano in genere – ne avevano decretato l’inesorabile fine, sentendoli come superati. I travestimenti del Conte e lo scatto viperino di Rosina hanno superato, saldi, con il loro vaporoso sorriso e la loro freschezza, il Romanticismo melodrammatico col suo palpitante sentimentalismo. L’untuosa falsità di don Basilio non ha perso la sua carica buffa e la sua forza comica anche di fronte all’uragano teatrale di Verdi che, con la sua parola scenica, ottenne un’inimmaginabile tensione drammaturgica che finì per identificarsi con il melodramma stesso. Il crudele sadismo reso comico, perché inefficace, da una inguaribile dabbenaggine di don Barolo ha avuto ragione persino del Verismo, con le sue passioni estreme e laceranti, descritte e sentite come reali.
Ma anche oggi, dopo l’ubriacatura della Rossini-renaissance, di fatto – e lo dico con molto dispiacere – solo questo capolavoro è l’unica opera di Rossini ad essere sempre presente in tutti repertori; persino quando si sono conosciute le altre grandi ed indiscutibilmente eccezionali prove del grande Pesarese e si più ben disposti – da parte del pubblico, oltre che da parte degli esecutori più tecnicamente agguerriti e consapevoli – a conoscere ed a sostenere le difficoltà esecutive di altri lavori, solo la vicenda di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais continua a dimostrarsi quanto mai viva: questi personaggi sivigliani, solitari nel catalogo rossiniano, vispi come non mai, senza accusare i quasi duecento anni che assolutamente non dimostrano, continuano ad ordire trame, a scambiarsi licenziosi biglietti amorosi oppure ad essere ingenuamente gabbati, facendoci così sorridere, divertire, ma anche ammaliandoci, commuovendoci e facendoci riflettere sulle meraviglie della giovinezza e sullo squallore di certa impenitente vecchiaia.
È inutile soffermarsi sull’indagine di questa eccezione e ricercarne la causa o nel valore straordinario della musica o nella creazione dei personaggi o in mille altre caratteristiche. Ci si deve però porre mente quando si decide di pensarne un allestimento.
Il barbiere di Siviglia ha avuto questo destino privilegiato, ma ha dovuto scendere a patti: la notorietà si paga. È un assioma, ma spesso – soprattutto quando si parla di teatro – non è poi questo gran danno! L’opera ha subito ed ha accettato – con la benevola riluttanza, la praticità, la sete di vita e la scaltrezza dei suoi personaggi – le mille variabili che hanno quanto meno mutato, se non deformato, i suoi propri connotati musicali; infatti nel periodo che abbraccia la fine dell’Ottocento ed i primi anni Sessanta del Novecento, per restare in repertorio il Barbiere ha dovuto accettare compromessi, talvolta anche grandi. E – come dicevo – ha pagato la sua notorietà con il doversi adeguare, in tali casi anche patteggiando e molto, al nuovo modo di concepire il teatro buffo e rossiniano, da ogni angolatura possibile: vocale, musicale, scenica ed orchestrale. È nata dunque nuova lettura, i cui confini sono stati dettati dalla tradizione. Questa nuova lettura dell’opera ha vinto e, vincendo, sopravvive ancora oggi. Il motivo di questo successo è molto semplice: il grande valore che ha nell’opera lirica la prassi esecutiva. Ci si pensa sempre troppo poco, ma è la prassi esecutiva che fa vivere il teatro lirico.
È di questa tradizione– questo è il merito degli studi musicologici e del meritorio ruolo pratico svolto da tanti artisti in scena – ciò di cui io in maniera consapevole mi voglio riappropriare. Lo si può fare con cognizione diversa, ben più profonda e perciò con puntualità e misura. Per questo il mio allestimento – sia da un punto di vista visivo sia da quello narrativo e dinamico dei movimenti scenici – sarà molto tradizionale: vorrà essere l’immagine di quella Siviglia dai colori decisi di tanta oleografia ottocentesca e coerentemente i personaggi saranno abbigliati con quei costumi che li hanno resi noti, riconoscibili e li hanno fatto tanto amare dal pubblico. Un Figaro con la sua brava retina verde tra i capelli, a mo’ di bravo manzoniano, ed un don Basilio – secondo la personificazione leggendaria del grande Fëdor Ivanovič Šaljapin – magro ed allampanato. Anche la regia seguirà quindi, con questa consapevole idea, la più consolidata tradizione. Come potrebbe Rosina cantare la cavatina Ma se mi toccano (atto primo, scena quinta) senza un ventaglio deliziosamente poggiato sulla guancia come ha fatto il più celebre binomio di maestra ed insegnante, Elvira de Hidalgo e Maria Callas, oltre che interpreti di levatura storica del ruolo di Rosina?
Il problema è dunque opposto a quello che ci troviamo ad affrontare per la maggior parte delle opere: non poche ma tantissime le tradizioni, tutte codificate e però spesso fortemente o superate per il nuovo modo di intendere il teatro o semplicemente divergenti l’una dalla’altra. Per rendere tutto ciò coerente, attuale e misurato ma efficace, ho trovato una soluzione e ho deciso di fare come quando si legge (o meglio si rilegge) un classico: per interpretarlo bisogna rapportarsi ad un’auctoritas, in altre parole ad una personalità straordinaria che, con il suo genio, ha reso la sua regia a sua volta, per l’appunto, un “classico”. La mia auctoritas è dunque – e non poteva essere altrimenti – Jean-Pierre Ponnelle e la regia, con un accento della mia personalità, sarà un tributo a lui e alla sua inventiva, tanto originale quanto indiscutibilmente legata alla musica: “giusta” insomma, per rendere vivo e godibile questo melodramma comico, senza privarlo dei caratteri magari non propri della sua fisionomia originale, ma che noi consideriamo irrinunciabili, perché cristallizzatisi e germogliati in tanti anni per tornare poi a nuova vita dopo tanto indefesso cammino scenico.
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.
25 Marzo 2011 - Tosca
Io mi sono sempre ritenuto e dimostrato refrattario alla pratica, oggi molto usuale, di voler dare una lettura psicanalitica di personaggi operistici o di figure letterarie. C’è, però, un caso che mi ha fatto decisamente cambiare idea: Tosca. In questa mia scelta nulla è casuale: nel 1900 il plaudentissimo pubblico romano assiste alla sua prima rappresentazione e in quel medesimo 1900 la progredita e avanzatissima Vienna, animata da fermento culturale unico in tutto il mondo, si disinteressa, in modo quasi sospetto, alla pubblicazione di Die Traumdeutung (L’interpretazione dei sogni) di Sigmund Freud. Questo testo – di assoluto riferimento e base della psicanalisi moderna – mi è sempre sembrato legato a Tosca per una sorta di predestinazione.
Forse è per questa identità di date che mi sono sempre imposto di cercare di capire, più dal profondo, i moti dell’anima di Tosca. Figura in perenne divenire psicologico, si muove con una tensione che non si può che definire nevrotica, modalità psicotica isolata, per la prima volta, proprio da Freud; infatti, sebbene molte siano le figure nel mondo operistico che, mosse da brucianti e violente passioni, si spingono ben oltre la misura e la logicità delle scelte. Ci deve essere qualche cosa nella sua mente che la renda, a suo modo, coerente con se stessa. Dapprima la lacerante ed inspiegabile gelosia, illogica come il suo incontrollabile furore, in netto contrasto con la sua fede incrollabile nella Madonna e nei Santi, ma nel contempo questa ultima inconciliabile con la sua pronta volontà di divenire sensualmente prima merce di scambio, poi assassina ed, infine, suicida.
Elencando questi aspetti – a dire il vero veramente tanti per una sola donna – mi sono reso conto di avere presentato altrettante tipologie “operistiche”. Mi è balzato all’occhio un tratto fondamentale che avevo visto solo superficialmente. Per capirlo basta leggere la modalità con cui viene definito il suo personaggio sulla locandina, “Floria Tosca, celebre cantante”: ecco la vera chiave per interpretare tutto il mistero della sua psiche, questa è la vera modalità interpretativa. Tosca come donna vera non esiste: vive solo come cantante e come tale agisce. Ogni movimento anche nella vita in lei è una forma di arte, ogni gesto, ogni scelta, ogni sentimento sono la nuova e rituale rappresentazione di una sua grande creazione teatrale.
Tutte queste manifestazioni non hanno però la stilizzazione delle opere neoclassiche, cronologicamente a lei contemporanee nella finzione della vicenda, ma sono molto più vicine alle opere della Giovane Scuola o per meglio dire a tutto il teatro lirico a cavallo tra i due secoli; infatti il suo essere cantante è molto più vicino a quelli che possono essere i tratti di una grande diva della fine dell’Ottocento che di una di fine Settecento, come invece recita il libretto. Questo è spiegabile per il fatto che era pratica molto diffusa, negli anni a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, dare ad epoche anche molto lontane – e per questo dagli indefiniti tratti affascinanti – connotati emotivi, morali, etici e psicologici tipici del momento storico presente e non di quello che rappresentavano.
Mi sono reso conto che, sotto la patina della datazione del libretto, “giugno del 1800”, è celata proprio quella sensibilità psicologica tipica della fine del secolo. Il vero problema era come – sforzandosi di non travolgere troppo la vicenda e soprattutto i suoi chiarissimi ed inequivocabili confini storici – rendere questa idea.
Tra tutte le proposte possibili la più logica, anche perché è la più immediatamente identificabile visivamente, era quella di posticipare la vicenda durante un momento della dittatura fascista. Con questo cambio il resto poi è venuto in maniera consequenziale e logica: Roma è rimasta capitale, Scarpia si è trasformato da capo perverso e bigotto della polizia pontificia a spietato aguzzino della repressione fascista, così come i “volterriani” (atto primo, scene terza ed ottava) Angelotti e Cavaradossi si sono mutati in dissidenti, incarcerati per motivi politici, esposti a torture ed infine giustiziati.
Dopo aver deciso che dovevo muovermi in questa direzione la figura di Tosca cantante neoclassica ha lasciato il posto ad una immagine di una diva dei grandi palcoscenici degli anni Trenta. Questa fisionomia si è mostrata, in maniera inimmaginabile calzante e molto coerente riportando con sé il carattere proprio di quelle cantanti: le autentiche dive nel senso moderno del termine. Il vero problema era come mostrare il carattere di una Tosca sempre “cantante” e di come trasmetterlo facilmente al pubblico. La soluzione, anche in questo caso, è stata una intuizione: le foto di scena della diva stessa. Durante la rappresentazione dell’opera verranno, infatti, proiettate della foto di scena di Tosca-Diva ritratta nei momenti più intensi delle sue creazioni o in pose artefatte tipici atteggiamenti da studio di posa. Chiara diviene questa continuità di carattere tra Floria – donna – e Tosca – cantante –, e questo è il mezzo più immediato: vedere, accanto una all’altra, Floria rivestire nella sua vita i panni ora di questo o di quel personaggio operistico e doppiarne non solo i gesti, ma anche la sensibilità, le scelte, i comportamenti, gli eccessi e le passioni divenendo così La Tosca. Eccola quindi gelosa come Santuzza, irata come Norma, credente e turbata, ma mistica e suicida come Suor Angelica.
Forse questa lettura di Tosca toglierà la poesia un po’ oleografica di alcune scene e di certe dinamiche ormai codificate con cui abbiamo imparato ad amarla. Questa mia interpretazione vuole, però, evidenziare, con mezzi inusuali, tratti insiti da sempre nella sua figura, ma forse meno comprensibili in un codificato e tradizionale allestimento.
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.
29 Aprile 2011 - Aida
Aida è un titolo celebre. Non stupisce, quindi, il fatto che, a causa della sua fama, il suo nome finisca spesso per coincidere con l’essenza stessa del melodramma ottocentesco. Questa sua notorietà è legata certamente non solo alla felicità della sua invenzione musicale e alla sua generale validità drammaturgica, ma anche, ed in forma forse ben più evidente, alla sua sontuosa teatralità. In altri termini molto del fascino di Aida va ricercato nella sua struttura operistica: il grand-opéra. Il suo clima maestoso e raffinato ne sono l’esempio più eloquente, come la presenza dei ballabili, delle grandi scene di massa e, sul piano prettamente drammaturgico, quel contrasto vivissimo tra affetti personali, profondi e totali, e le regole più forti del singolo e leggi più profonde della personale volontà.
Aida, però, non è solo questo; il ricercare la chiave di volta dell’interpretazione di questo capolavoro solo in questa magniloquenza spettacolare contrastante con il sentire del piccolo personaggio può divenire un limite di prospettiva. Quando quest’opera venne commissionata a Verdi, questi decise di seguire il modello francese, sapendo bene che il suo talento l’avrebbe portato a ben altri esiti; infatti il carattere “parigino” è legato maggiormente ai tratti che insistono all’esteriorità del dramma e molto meno alla reale dinamica intima degli affetti, restituiti con la sua puntualità psicologica dalla scrittura musicale. A fronte del fatto che le scene ed i costumi erano, alla prima del Cairo, un capolavoro del grande atelier dell’Opéra, si deve sottolineare come i personaggi, che vi agivano, si esprimevano con una lingua decisamente italiana, non solo per il fatto di recitare il libretto dello scapigliato Antonio Ghislanzoni.
Ed ancora un altro è un punto da considerare come fondamentale: Verdi, sempre poco eloquente per quanto attiene alle ragioni programmatiche che stavano dietro ad ogni sua creazione musicale, fa, proprio conAida, una parziale eccezione. In una lettera, indirizzata proprio a Ghislanzoni e datata il 17 agosto 1870, ci offre una vera e propria analisi della sua modalità di comporre musica, saldamente legata al libretto ed a quella che egli stesso definisce “parola scenica”. In essa richiedeva espressamente al librettista «la parola che scolpisce e rende netta ed evidente la situazione». Questa puntualizzazione viene fatta dal compositore a proposito della stesura del Terzo Atto, che il musicista considerava il vero cuore dell’opera.
Pertanto, io stesso prenderò l’avvio da questo snodo scenico per chiarire il mio taglio narrativo. La cosiddetta “scena del Nilo” è il momento di massima tensione drammaturgica; la cura dedicata a questa sezione drammaturgica è comprovata da un altro dato: questo atto avrebbe avuto la struttura che noi oggi conosciamo solo dopo la sua prima milanese per la quale il compositore avrebbe aggiunto espressamente l’aria O cieli azzurri, divenuta una delle pagine più alte di tutta l’opera. Nel terzo atto si stempera la grande esteriorità dei primi due per acquisire, invece, una natura più intima, più spontanea e, per così dire, più verdiana. Ma il fatto che questo aspetto, nella scena del Nilo, sia più evidente ci offre la possibilità di descrivere per coglierli anche in altri momenti dell’opera. Si deve insomma leggere la vicenda nella sua totalità sapendo bene che, dietro alla magniloquenza da colossal quasi hollywoodiano, soprattutto le figura femminili sono personaggi reali, vivi e sensibili, che riescono ad esprimersi a pieno, nella loro più autentica personalità.
Questo è possibile solo lungo il Nilo alla luce della luna che illumina in modo soffuso i loro passi in un cammino più incerto e per questo più vero. Amneris, non più figlia dei faraoni, si mostra come una donna consapevolmente infelice per amore; spera di ottenere, affidandosi disperatamente alla preghiera, una corrispondenza emotiva da parte di un uomo che sa benissimo non la desidera. Aida, fragile a causa della sua condizione di inferiorità sociale, medita il suicidio e con malinconica lungimiranza è certa di non avere più la possibilità di rivedere la sua patria. Mossa, poi, da sensi di colpa, quasi in maniera incosciente, come una superba figura sofoclea legata ad un terribile destino immutabile, dopo un illusorio sogno di fuga diviene il mezzo di rivincita politica e militare nelle mani del padre e la causa della dannazione dell’amato. È su queste figure femminili che Verdi crea veri e propri caratteri scenici che per la loro forza ed originalità, si affrancano dallo stereotipato clima grand-opéra.
Anche a Radamès è assicurata magari una consapevolezza non altrettanto profonda, ma l’occasione di essere più vero e meno guerriero senza macchia e senza paura: il sogno. In un clima onirico e non stentoreo né magniloquente è da leggersi il celebre Celeste Aida. Lo stesso dicasi per la sospirata e non vissuta fuga, vagheggiata nel grande duetto del terzo atto ed infine nella scena della morte. Chiarissimo a questo confronto è la diversa prospettiva sua e quella di Aida: lui ancora arpionato alla speranza di una vita terrena, lei trasfigurata nella accettazione della morte.
Questi aspetti sono quindi i tratti che voglio evidenziare nella mia interpretazione di Aida. L’allestimento scenico sarà di base tradizionale e tradizionalmente rispettoso, ma non privo di una certa sensualità, come per esempio avverrà nella scena delle stanze private di Amneris. Per rendere possibile questo si proporranno delle proiezioni di grandi opere pittoriche di epoca vittoriana, che, contemporanee alla lettura scapigliata di Ghislanzoni, vedevano nell’antico Egitto, oltre che la maestà dell’opulenza, anche una sottile vena di erotismo dai tratti esotici. Nel terzo ed nel quarto atto, invece, le immagini proiettate si ispireranno alle celeberrime scene di Lila de Nobili, i cui bozzetti si rifacevano alla pittura di genere vittoriano e ne sfrondavano quel tanto di fasto per darne una lettura più intima, più disadorna, più malinconica più decadente. Infine per suggerire un clima di sogno ad occhi aperti e di evasione, tratto tipico non solo delle citate scene legate alla figura di Radamés, ma anche dei grandi momenti lirici di Aida, sarà presentata una corrispondenza fra lo scorrere di immagini sul fondo ed evocazione lirica legata alla voce, alla musica, alle parole, rendendole così realmente sceniche: un mezzo contemporaneo per rendere il tratto più antico e tipico del melodramma non esclusivamente verdiano, ma da Verdi sentito con inconsueta forza.
a cura del Prof. Valerio Lopane, musicologo e regista.